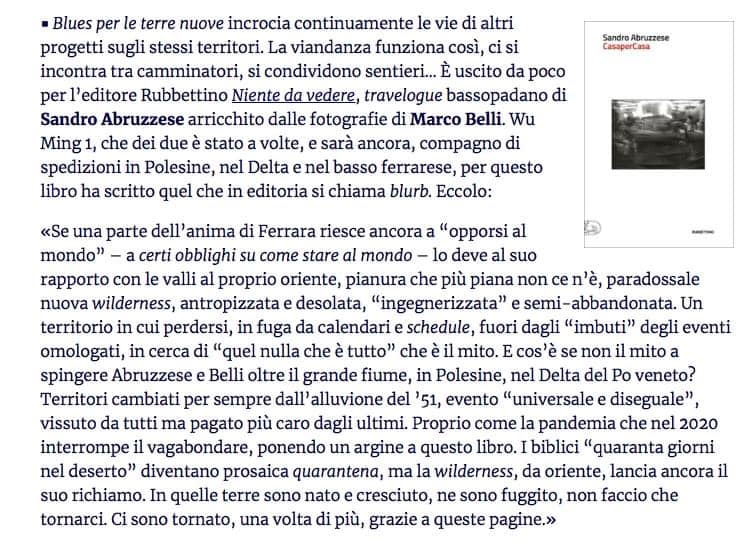Etichettato: letture
Badiou a Lendinara

Arrivo a Lendinara in una rovente domenica di inizio giugno con la giusta dose di curiosità dovuta alla lettura di qualche vecchio racconto di Gian Antonio Cibotto e subito provo per questa cittadina assopita lo stesso stupore provato a suo tempo nella vicina Fratta Polesine. Di Fratta avevo annotato che rappresenta un’altra storia rispetto al Polesine, che la sua grazia parla di Venezia più che della provincia di Rovigo. La bellezza di Lendinara non solo conferma quell’impressione, ma la rinforza: le sue piazze, il teatro, le numerose chiese, il Duomo, la grazia dei viali lungo l’Adigetto, insomma il corpo di Lendinara fa pensare a un luogo riuscito, privo di fantasmi.
Anzi, Lendinara sembra dire al visitatore dilettante come me che lei, al contrario di altri, nonostante le catastrofi e le alluvioni, nonostante il significativo calo della popolazione successivo alla rotta del ’51, ebbene ce l’ha fatta. Anche le campagne abitate e curate lo ribadiscono. Tutto d’intorno rassicura che il rapporto col mondo moderno a Lendinara è stato comunque positivo. Magari il successo, il dinamismo economico, la cura del patrimonio artistico, lo si deve al vento del Nord, a questo suo proiettarsi verso locomotive dello sviluppo come Padova, Vicenza, Verona, chi può dirlo? Nel dubbio, lo chiedo al benzinaio sulla statale verso Rovigo. Lui ascolta annoiato, si guarda le unghie, poi conferma con una frase secca che questo è Polesine, ed è sempre stato Polesine. Non c’è altro da dire.
E allora perché girando alla controra in questa città a tratti sontuosa, mi viene in mente uno come Alain Badiou?
Una volta tornato a Ferrara con questo tarlo nella mente, vado a riprendere i miei appunti sul filosofo francese e subito, con una sola frase, risolvo l’arcano: tutto il reale, scrive, si rivela nel crollo di una finzione. Ecco la risposta che cercavo. Una città riuscita come Lendinara, una piccola città di una qualsiasi democrazia capitalista europea, se è un artificio in grado di generare e appagare le aspirazioni di chi la vive, è pure un luogo che, con la sua finzione, con i bar, le vetrine, le passeggiate, a maggior ragione maschera e ottunde il reale. Voglio dire che le sue illusioni sono in grado di far dimenticare il fragile, il non riuscito, il fallito dell’esistenza. E allora per chi come me va in giro per cercare il reale, anche se a volte in maniera balzana, lo ammetto, Lendinara è un altro limite, un’ennesima soglia, come la Romea, come Chioggia e Ravenna o Baricella. Il suo campanile altissimo, per esempio, l’aria morigerata del borgo cattolico, sono come una rappresentazione teatrale o un romanzo di Parise. Lendinara, come qualsiasi altra città, propone il suo scenario perché ha una sua forza o idea di mondo da mostrare all’avventore. E questa forza non rende accessibile il fallito dell’esistenza come invece accade nei luoghi fragili: a Pila, a Papozze, a Ariano Ferrarese, a Berra o Villanova Marchesana.
Per accedere al reale dell’Italia occorre qualcosa di non riuscito, rimasto fuori da piani e progetti nazionali o regionali, qualcosa come parte del Meridione, delle isole, delle montagne italiane. Per comprendere l’Italia e il mondo occorrono luoghi che non riescono a prendere la forma che il moderno pretenderebbe da loro, né riescono a sposare armonicamente l’antico e il nuovo, come fa Lendinara, e per questo restano a margine, tramortiti o ignorati.
Se ci pensiamo bene, la maggior parte del globo è fuori dal mondo riuscito e per questo subisce lo sfruttamento delle risorse del pianeta, l’espropriazione di ingenti ricchezze, senza ottenere in cambio nemmeno l’acqua potabile. Allora il reale ci parla di diseguaglianza, ecco perché i luoghi esuli, dimenticati, e le persone in qualche modo esiliate con loro, riflettono la mancata riuscita della democrazia. Anzi, per dirla con Badiou, la democrazia diviene anch’essa finzione, complice di uno Stato che finge di inseguire dei valori democratici, per garantire invece posizioni acquisite, configurazioni e ordini costituiti.
Per non avvertire questa finzione democratica abbiamo bisogno di un’intera industria globale dell’intrattenimento e dello spettacolo che tramite i soliti volti noti trasforma in merce a scadenza breve qualsiasi argomento, dall’Ucraina all’ecologia. Immagini fittizie, film e canzoni irreali, televisioni e radio scanzonate perpetuano la distrazione dal reale e quindi dal politico.
Viaggiare nel Polesine allora vuol dire avere a che fare costantemente col reale, è il potenziale che ancora i luoghi più fragili mettono a disposizione del viandante.
Se ogni città è un sogno, se ogni luogo è un mondo, il Polesine e l’estremo limite della pianura ricordano che tutti dovrebbero poter sognare gli stessi sogni, e che se il fragile permette di costruire senza superbia e tracotanza, perché mostra ciò che manca, i luoghi del potere restano troppo spesso preda di piani egocentrici per cui non esitano ad accentrare e accumulare, in una spirale catastrofica, altro potere.
s.a.
Wu Ming 1 su Niente da vedere
MERIDIONALI SI DIVENTA: MASTRONARDI NELLA QUESTIONE ITALIANA
*Articolo pubblicato in precedenza qui su Le parole e le cose
di Sandro Abruzzese
Letteratura e Questione italiana
Nel capitolo dedicato al miracolo economico della sua Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi Paul Ginsborg sottolinea giustamente come il 1960 sia l’anno de La dolce vita e di Rocco e i suoi fratelli, per poi concludere chiosando: “Non vi fu nel campo della produzione letteraria di quegli anni un’opera che potesse rivaleggiare con il Rocco di Visconti”. È questo passaggio, poche righe, a riportare alla mia mente Lucio Mastronardi e a spingermi qui a una rilettura de Il meridionale di Vigevano, ultimo tassello della trilogia sulla città padana.
Il fatto è che, se volessimo tracciare un percorso non solo del boom economico, ma relativo alla rappresentazione della Questione italiana (o meridionale che dir si voglia), – di cui il boom è certo una delle tappe più rilevanti – in questa prospettiva più ampia, il terzo libro del settentrionale oriundo Lucio Mastronardi apparirebbe in una luce tale da risultare addirittura indispensabile. E invece il vigevanese, con Bianciardi, viene perlopiù relegato al ruolo di autore del boom, del microcosmo Vigevano, mentre a carattere nazionale altri sono i nomi che sovvengono: da Verga, Silone, Alvaro, Carlo Levi, Russo, a Ottieri, Strati, per farne alcuni.
Ebbene, ho come l’impressione che Mastronardi resti confinato nello spazio circoscritto dai primi due grandi libri e che l’attenzione dedicata dalla critica al meridionale non solo sia nel complesso minore, ma a volte generi vere e proprie stroncature. È il caso di Gian Carlo Ferretti che vi trovò “un linguaggio incerto”, una struttura meno coinvolgente, un “discorso (…) descrittivo, sproblematizzato, nel quale non c’è più né cattiveria né divertimento né disperazione”.
Per la verità troviamo disaccordo critico su buona parte delle opere del vigevanese pure incrociando i giudizi autorevoli di Contini, Calvino e Asor Rosa. Contini amerà Il calzolaio ma non Il maestro. Per il ligure è Il calzolaio(lettera del 3 dicembre 1960) a dare una visione dell’umanità espressa in maniera “oggettiva e unitaria”. Asor Rosa invece ritiene lo stesso libro “rozzo e sommario”, tuttavia il più penetrante.
Se non c’è unanimità è però sempre Calvino, colui che seppe essere amico di Mastronardi per molto tempo, soprattutto dopo la dipartita di Vittorini, a confessargli: “la cosa più bella che hai scritto in vita tua è il capitolo dei meridionali al telefono pubblico (…)”. Certo anche il ligure non lesina, con la consueta franchezza, alcuni rilievi, e infatti il vigevanese riscriverà più volte, prassi consolidata, fino all’uscita, nel ’64.
In casa d’altri
La trilogia di Vigevano nel suo insieme assume una fisionomia completa e finisce per perdere il carattere frammentario dei singoli libri. Si tratta di volumi complementari, in cui Il meridionale di Vigevano sembra avere il compito di restituire all’esodo delle masse contadine uno sguardo prospettico particolare. Si guarda ancora alla Vigevano del boom, ma stavolta il punto di vista è a un tempo interno e esterno. In esso, infatti, l’io narrante e alter-ego di Mastronardi è un impiegato meridionale del fisco, testimone coinvolto eppure distante, a tratti implacabilmente alienato alla maniera del Silvio D’Arzo di Casa d’altri, e per questo in grado di riportare con estrema efficacia l’incontro-scontro tra meridionali e padani.
Beninteso, fin dal principio, attraverso un condensato di forza icastica e sarcasmo, Il meridionale di Vigevano getta il lettore nel magma di un nuovo mondo: “Quando i portinai possono combinare un matrimonio”, scrive l’autore,“sono contenti che sembrano loro gli sposi”. Gli fa eco la teoria delle razze della portinaia: “I figli nati fra calabresi e vigevanesi sono più intelligenti che belli. I figli nati fra siciliani e vigevanesi sono piuttosto piccoli. Fra abruzzesi e vigevanesi vengono fuori figli, uhm!, così e così (…)”, ricorda con ironia lo scrittore, egli stesso figlio di un abruzzese nativo di Cupello, sposato a una maestra vigevanese.
In questa Vigevano dunque i meridionali sono ormai dappertutto: affollano cortili di vecchie cascine, sale di conventi, gremiscono bagni pubblici, rive di fiumi, canali: “I figli fanno i muratori (…) Le figlie fanno le giunture. I genitori vanno in fabbrica, e si portano ancora a casa del lavoro. Anche i piccoli hanno lasciato la scuola per fare i garzoni”.
Se uno dei segreti del boom è il basso costo della manodopera al cospetto del neonato mercato unico europeo, Mastronardi ne racconta il carattere caotico, disperato e disordinato, che assume le forme di una vicenda individuale o familiare, capace di tratteggiare le fattezze di un nuovo aberrante spirito nazione. L’Italia di Mastronardi è priva di una strategia collettiva, orfana di mano pubblica, i nuovi arrivati vi si arrangiano in tuguri, la definizione di “miracolo” non può che apparire una beffa. Come può una nazione che si avvia a tale ricchezza, vien fatto di pensare col meridionale, destinare così poco a una parte più che consistente della sua popolazione?
Tra il ’51 e il ’74 più di quattro milioni di italiani provenienti dalle aree maggiormente penalizzate delle fasce collinari e montane della penisola, quasi del tutto abbandonate al loro destino, lasceranno il Sud e le aree interne italiane. Contestualmente Vigevano passa da poco più di quarantamila abitanti a circa settantamila. I nuovi arrivati saranno accolti da un razzismo manifesto, disposti a orari di lavoro massacranti, senza alcun grado di sicurezza: “Voi meridionali avete il senso dell’imprudenza”, fa dire alla moglie di un funzionario Mastronardi, “(…) Vedete quello? – seguitò indicandomi un muratore – Quello ha famiglia. Dico: ci vuol niente a cadere (…) Anche quello ha famiglia (…) Sa, questi sono venuti qui alla ventura (…)”.
Una massa di persone disprezzata, ricattata da contratti brevi e, spesso, come poi mostrerà Gianni Amelio in Così ridevano, organizzata dall’opportunismo di caporali compaesani o corregionali. È ancora Mastronardi, puntuale, a scrivere a riguardo della “maffia” di un tizio che “prometteva gente che si contenta. Veniva giù al paese (…) si faceva dare un tanto da quelli che volevano la sistemazione, e un tanto dagli industriali”.
In fin dei conti si tratta degli albori di un’Italia priva di guida e valori collettivi che abbiamo imparato a conoscere, in cui l’unica strada sensata sembra essere il manifesto egoismo che darà luogo all’ossessione monomaniacale della roba e del denaro. Un mondo improvvisato, certo, e per questo ridotto a pura questione personale, in cui si impone il problema della casa – La speculazione edilizia di Calvino è del ’63 – ovviamente nell’urbanizzazione incontrollata, preda degli avvoltoi del settore edile.
La scena di Calvino e il nuovo mondo
Il meridionale di Vigevano pullula di un’umanità rurale: “Nel mio paese c’è gente buona e cattiva; è come dappertutto, nel mio paese. Non è mai successo niente di brutto al mio paese”, sente il bisogno di dire tra sé e sé il protagonista durante la scena del telefono di cui parla Calvino nella sua lettera.
Siamo in una domenica cittadina, nell’aria pregna di fumo della saletta della Stipel, la telefonista chiama uno per volta i paesani in fila per telefonare alle famiglie lontane. Arrivato il suo turno, però, l’io narrante è preso da un improvviso pudore che gli piega le gambe e la voce. L’idea del paese natale lo tramortisce. L’operatrice prosegue con la girandola infinita di nomi dell’Italia rurale: Croce Ferrata, Monterosso, Stornara, Roccapalomba, Partinico, Cinquefrondi, Grazzanise, Ginosa. La scena è dotata di un ritmo e di un’intensità tali che non sfugge al lettore Calvino.
Altrettanto potente è, poco più avanti, l’alterco tra il protagonista e l’aggressiva fidanzata Olga, la quale, vistasi scoperta nella sua povera doppiezza, per ripicca tenta di raggiungere il paese del fidanzato per “giudicarne la gente”. Sicché arrivata in stazione ferroviaria, sale su un vagone e sventola il biglietto del treno: “il treno era preso d’assalto. Sull’uscita c’erano padri con bambini in braccio (…) Io glieli mostravo a Olga. Le mostravo i meridionali, che anche loro guardavano la locomotiva e il treno come bambini”, racconta lo scrittore.
Resta il tempo per l’epilogo della storia di Consiglia. È qui che si chiude, con una carrellata sui campi avvizziti di questi contadini-operai venuti da lontano, Il meridionale di Vigevano.
Ora, seguendo i soccorritori, egli si ritrova nell’umile abitazione della sua compaesana Consiglia: “(…) qualche metro quadrato di spazio, con tre pareti di cartone e fòrmica”. Fa in tempo a vedere la donna avvicinarsi all’orecchio del figlio: “Quante volte te lo dicevo, Cosimino, che qui non ci stiamo. Che non è posto, questo, per noi”.
Nel mezzo di questi poli estremi vi sono, nel meridionale, tutti i meccanismi di rimozione di qualsiasi sradicamento: i tic, gli sconquassi familiari, l’indigenza, la paranoia, la nevrosi. L’alter-ego dell’autore attraversa rassegnato furibonde gelosie, subisce i rimbrotti e gli ammiccamenti dell’imprenditore Esposito: “Li terroni non sanno fare proprio niente (…) più che figli non sanno fare”. “Più che un terrone non può essere (…) i terroni non hanno il senso del rispetto della roba degli altri!”.
“Gli Esposito”, egli mostra, sono balzani e bipolari, e d’improvviso “parlavano di noi meridionali (…) che siamo una razza superiore, inutile dire, troppo superiore”.
C’è poi l’invidia per chi, come il napoletano Pedale, ha fatto ancora più fortuna e può permettersi di assumere solo operai settentrionali e ne ha circa 400. Nel suo ufficio campeggia un cartello con su scritto: “vietato l’ingresso ai cani, ai porci, ai terroni!”.
Oppure l’irpino Oreste, armato di pistole, coltelli, sempre pronto alla rissa per difendere il suo desueto, anacronistico concetto d’onore.
Ci sono le mondine, anch’esse meridionali, che cantano, verso l’imbrunire, il lamento della vedova nelle risaie. La sera “la strada era piena di contadini diventati operai”. Le strade di Vigevano ormai portano i nomi di via Campania, via Calabria, via Sicilia, e via dicendo.
Revisioni
Nel meridionale di Vigevano, dunque, va in scena la brutale forza centripeta del capitalismo spontaneo all’italiana. E se è vero che il Mastronardi del meridionale è già uno scrittore in crisi d’ispirazione, a distanza di decenni gli stessi aspetti ritenuti da Gian Carlo Ferretti più deboli, sembrano tramutarsi nei suoi principali punti di forza. Si apprezza cioè del meridionale, oltre all’assenza di toni elegiaci in un argomento a cui non è estranea la componente nostalgica, quella distanza dal mondo e dagli altri in grado di connotare l’io narrante trincerandolo in una misurata rassegnazione. La precisione descrittiva e visuale, il carattere frammentario, gli scatti, la prevalenza del nitore sui brevi obnubilamenti, si innestano in dialoghi semplici, terragni, eppure necessari, che restituiscono un costante senso del vacuo, insieme all’aderenza a una realtà trasfigurata dalla sua lente d’ingrandimento. Il narratore è sì trascinato dagli eventi, tra pause di parole taciute, giudizi sospesi, ma quella stessa postura accondiscendente favorisce la rappresentazione di un’umanità degradata, grottesca e irrazionale. È cioè l’arma di una protesta silenziosa e isolata, basata su un arreso pudore al cospetto degli accenti e delle linee di fuga del familismo italiano, della montante cultura di massa consumistica. Le accelerazioni, i cosiddetti difetti di struttura, ripresi oggi, alla luce dell’omologazione che l’industria culturale è andata via via imponendo alla letteratura, diventano elementi dinamici del tutto coerenti con uno scrittore viscerale e riottoso. Uno scrittore che è sempre marcatamente autobiografico, e si esprime attraverso una lingua viva, intensa, spontanea, incapace di lirismo, anzi fitta di brevi invettive e sproloqui. Una lingua, giusto per schematizzare, votata al plurilinguismo e per questo vicina a un filone che ha dei precedenti in Gadda come in Testori.
La rivolta impossibile
Quella di Mastronardi è, come ha giustamente titolato Riccardo De Gennaro nella sua preziosa biografia dell’autore, una rivolta impossibile. Ricostruendo il percorso del vigevanese, De Gennaro sottolinea come tra i motivi di fondo della sua opera vi sia una rivolta dai tratti marcatamente politici e esistenziali, dunque non ascrivibile, se non banalizzandola, esclusivamente ai problemi psichici e familiari. Vi è nella vicenda dello scrittore, secondo il biografo, una ricchezza e molteplicità di piani che va dal difficile rapporto con la figura ingombrante del padre Luciano, alla fragilità di nervi, a cui si somma la sua strenua lotta contro la spinta omologatrice degli anni in questione. Lo scrittore è quindi pienamente ascrivibile alla storia intellettuale di quegli anni al pari dei Bianciardi, Pasolini, Calvino, Sciascia. Di certo lo aiuta nella scrittura questa sua capacità di captare il mondo circostante per osmosi, la sua forza istintuale, alimentata dal sentirsi esule in casa propria, in un legame con la città fatto di consuetudine e repulsione.
Mastronardi, poi, possiede questa sorta di fiuto per la realtà, confermato dalla famosa inchiesta del gennaio ’62 condotta da Giorgio Bocca sul Giorno, Mille fabbriche nessuna libreria, dove si annota con sarcasmo: “Ebbene, se voi credete che la montagna dei capitali produca redditi adeguati vi sbagliate. Altrove i redditi industriali saranno del dieci, del venti per cento, qui neppure dell’uno. Si vede che interi carichi di scarpe colano a picco nel tempestoso oceano, forse migliaia di macchine utensili vengono travolte dalle piene del Ticino (…).
Quasi vent’anni dopo, nello scandalo delle false fatturazioni scoppiato in tutta Italia, emerse che nella sola Vigevano, così riporta Guido Crainz nel Paese reale, “andavano in galera 29 esattori dell’Iva su 30”. Lo scandalo condusse Maurizio Chierici, in un articolo per il Corriere della Sera, a ricordare che se Mastronardi fosse stato ancora in vita, a questo punto avrebbe potuto scrivere L’esattore di Vigevano. Evidentemente anche stavolta, al di là della boutade, sfuggiva ai più Il meridionale di Vigevano, libro incentrato sulla corruzione italiana, oppure il ruolo di personaggi ricorrenti nella trilogia come l’avvocato siciliano Racalmuto, definito da Domenico Scarpa “un piccolo dio dei ladri e dei commercianti”.
Meridionali si diventa
Intendiamoci, qui non si tratta solo di annoverare Mastronardi tra i grandi del Secondo novecento. Nella trasfigurazione di Vigevano vi è un essenziale contributo alla decodificazione della storia italiana recente, contestualmente alla messa a fuoco di linee di continuità e storture nazionali che arrivano direttamente ai nostri giorni. Ciò che Mastronardi scrive, dunque, in linea con ciò che il cinema e la letteratura della Questione italiana rappresentano nel Secondo dopoguerra, oggi confligge vistosamente con l’immaginario mediatico prodotto negli ultimi trent’anni. Sicché se lo scrittore del Meridionale sottolinea i prodromi dei futuri problemi del paese – l’assenza endemica di riforme strutturali, la creazione di un sistema di potere burocratico ipertrofico e inefficiente fondato sulla tolleranza dell’evasione fiscale e del lavoro nero, sulle tangenti e i voti della malavita – questi affosseranno definitivamente le speranze di riduzione degli abnormi divari del paese, prima di sommare, al malcontento rassegnato del Sud, quello inedito del Nord per “Roma ladrona” e i terroni. Queste e non altre sono le ragioni principali del fallimento italiano.
È a questo punto che, con Tangentopoli e l’irrompere della Questione settentrionale nella scena politica italiana, scrive Guido Crainz: “Il Sud diventa luogo centrale e simbolico del degrado, con un salto di qualità nella stessa percezione del problema”. Si dimentica cioè, aggiunge Vito Teti nella Razza maledetta, che Tangentopoli ha la sua capitale a Milano, e invece “il Nord si scopriva improvvisamente sfruttato (…) vittima dei meridionali e dei partiti che avevano curato soltanto i loro interessi”. Ecco che gli stessi “ (…) meridionali che avevano popolato città, campagne e paesi del Nord, riempito fabbriche, costruito economie”, come Mastronardi attesta, “(…) diventavano, per i leghisti, i responsabili della corruzione e degli imbrogli portati avanti dai partiti di governo, al Nord e al Sud, dal 1948 in poi”.
Ebbene, ogni polarizzazione, ogni schematica opposizione noi-loro, italiano-straniero, nord-sud, ci ricorda che il capro espiatorio della balcanizzazione ha la doppia funzione di fornire alibi, magari vittime, per salvare i veri colpevoli.
È la lunga stagione berlusconiano-leghista a produrre il ribaltamento della percezione generale della Questione italiana per una riedizione dell’antico pregiudizio antimeridionale. Si rimuove quella fusione “vigevanese” tra Nord e Sud, quel Mezzogiorno padano sostanzialmente mai interrottosi nel corso della storia repubblicana, eppure – sostiene ancora Teti – “era facile accorgersi che le due entità geografiche, culturali, morali erano ormai mescolate, erano l’esito di un processo unitario di oltre un secolo (…) sia nei successi che nelle responsabilità, sia nelle conquiste che nelle degenerazioni”.
La complementarità delle varie parti d’Italia nel decennio scorso è stata sapientemente cristallizzata da Roberto Saviano – uno dei pochi giornalisti di una certa visibilità mediatica a battersi strenuamente e costantemente contro le falsificazioni leghiste – il quale in Gomorra racconta, insieme al sistema-paese e all’economia-mondo, lo smaltimento illegale dei rifiuti dell’Italia industrializzata nella Terra dei fuochi, unendo così ancora una volta l’Italia nell’inestricabile intreccio delle sue tante contraddizioni.
Altro discorso meriterebbe il successo dei pamphlet neo-borbonici alla Pino Aprile, che rilanciano la polarizzazione schematica dello scontro, finendo implicitamente per assolvere le classi dirigenti meridionali e rivolgersi contro il nemico esterno. Si attua così una sorta di leghismo meridionale più raffinato e erudito, che a sua volta, facendo un uso distorto di reali accadimenti storici, preferisce imputare ogni colpa della storia d’Italia alla sola parte settentrionale del paese. È la conferma dell’incapacità di farsi “soggetto di pensiero”, direbbe Franco Cassano, di auto-rappresentarsi senza cadere in patetici orgogli identitari, o in narrazioni irreali e emotive di un fantomatico “cuore meridionale”.
Un Sud che sembra sempre più condannato a dover essere speciale, in cui la sudditanza di un nuovo contro-immaginario generato per reazione nasce perché da troppo tempo in molte sue parti non si è messi in condizione di diventare normali.
Il resto è storia recente. La Lega al governo occupa le tv e rompe definitivamente argini e indugi: abituati ai Borghezio e Calderoli, a Zaia e Salvini, non desta alcuna sorpresa il recente siparietto Feltri-Giordano sui “meridionali inferiori”. È il solco di un terreno arato da decenni proprio grazie a tv, radio e pamphlet giornalistici.
Il leghismo, nel frattempo strumentalmente passato dalla secessione al federalismo, partendo da alcune ragioni di fondo, ha abilmente imposto il suo lessico e la sua agenda politica alla nazione, tracimando nello stesso Partito democratico per l’attuazione di imprecisate quanto frettolose proposte di autonomie regionali differenziate. Questa paradossale ancorché granitica deriva populistica e xenofoba fonde spinte disgregatrici e nazionalismo, religione e linciaggi mediatici. Grazie alla crisi economica del 2008 e alla martellante Questione migranti, per via dell’insipienza di un centro-sinistra in perpetua crisi d’identità, ingrossa le sue file fino a portare alla beffa del voto in massa dei meridionali per la Lega di Salvini. Siamo all’ultimo colpo di teatro.
In fondo quel che è successo in questo ventennio è l’aver abdicato, come stato e classe dirigente, al’’idea di una reale unione dell’Italia. La sfiducia di questi anni trasforma la Questione meridionale alla stregua di dispute folcloristiche tra tifoserie. Allora leggere Il meridionale di Vigevano oggi è più che mai opportuno per combattere i clamorosi e a volte voluti strabismi, e per ripartire da alcuni essenziali punti fermi sulla rappresentazione della realtà nazionale.
Bibliografia essenziale
Alberto Asor Rosa, Uno scrittore ai margini del capitalismo, in Quaderni piacentini, anno III, Gennaio 1964
Italo Calvino, Lettere, 1940-1985, Mondadori, Milano, 2000
Guido Crainz, Il paese reale, Donzelli, Roma, 2012
Guido Crainz, Autobiografia di una Repubblica, Feltrinelli, Milano, 2009
Riccardo De Gennaro, La rivolta impossibile, vita di Lucio Mastronardi, Ediesse, Roma, 2012
Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, Il Mulino, Bologna, 2013
Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1996
Lucio Mastronardi, La trilogia di Vigevano, Einaudi, Torino, 1994
Roberto Saviano, Gomorra, Mondadori, Milano, 2006
Domenico Scarpa, La farfalla vola nel prato, pref. a Il maestro di Vigevano, Utet, Torino, 2007
Vito Teti, La razza maledetta, Manifestolibri, Roma, 1993
Vito Teti, Maledetto sud, Einaudi, Torino, 2013
Langer e Leogrande: dialogo tra le frontiere
*Articolo uscito in precedenza qui su Le parole e le cose
La recente pubblicazione del volume Dialogo sull’Albania (Alphabeta Verlag 2019), curato dall’insegnante e scrittore Giovanni Accardo, incrocia i percorsi intellettuali di Alexander Langer e Alessandro Leogrande a cominciare dall’attenzione che entrambi hanno dedicato al paese balcanico nel corso della loro vita. Un lavoro che, riportandoci alla caduta della Cortina di ferro orientale, ci offre l’occasione per ripercorrere alcune tappe del passaggio di consegne tra i due osservatori sull’Albania, nonché di tentare di comprenderne, almeno in parte, le motivazioni. Si tratta di un intreccio di prospettive che, affrontando temi delicati quali il ruolo delle frontiere, la capacità di dialogo interetnico, l’identità, la memoria, e la tragedia del Mediterraneo, apre a una ripresa di argomenti costantemente al centro del discorso politico odierno.
Frontiere
“Le frontiere cambiano, non rimangono mai fisse. Si allarga l’Europa e mutano i punti di ingresso. Scoppiano guerre, cadono dittature, (…) e si aprono nuovi varchi. I varchi a loro volta creano un mondo”, ha scritto Alessandro Leogrande nella Frontiera, tassello imprescindibile di quello scavo alla ricerca di categorie interpretative della storia recente che è la sua produzione intellettuale.
In questo libro Leogrande, ricostruendo il mondo degli altri, e lottando contro il silenzio che avvolge le vittime del Mediterraneo, raccoglie pazientemente storie che finiscono per tratteggiare le linee di un unico sistema concentrazionario dai confini variabili. L’Eritrea di Afewerki, uno dei fili che consentono all’autore di collegare le ex colonie italiane allo sviluppo di feroci dittature, non è altro che un campo di concentramento in grado di riportare la mente ai peggiori misfatti del ‘900.
E a una sorta di sistema concentrazionario rimandano le insidie e i pericoli dei migranti. Nel viaggio di esuli, profughi e fuggiaschi, è lo stesso Leogrande a parlare di sommersi e salvati in preda a poliziotti sudanesi, trafficanti libici, campi di detenzione, tortura, e infine naufragi. La legge a cui le condizioni dei viaggi conducono i naufraghi, poi, è quella della sopravvivenza, del pensare per sé. Anche in queste storie vi è, come per i profughi seppelliti al cimitero di Agrigento, la scomparsa dei nomi, e il ritorno di semplici numeri identificativi, spesso finiti su delle croci. Per i salvati, quando va bene, non vi è che il caos dell’accoglienza italiana, con tutti i suoi limiti e umori politici.
Leogrande segue i confini europei, da Lesbo a Lampedusa, finché la vicenda del curdo Shorsh non lo conduce a Bolzano, un’altra provincia in cui il fascismo nel corso del ’900 ha generato tensioni tali che oltre settant’anni di Repubblica non sono riusciti a risolvere, e in cui la composizione plurietnica della regione continua a vivere di rispettive separazioni e diffidenze.
È in questo piccolo ginepraio italiano che emerge la figura carismatica di Alexander Langer. Ed è proprio al politico di Sterzing che Leogrande guarda quando si fa, come in questo libro, esploratore di confini, per superare ostacoli e protendersi verso gli altri. È egli stesso, quasi in chiusura del libro, a ribadirlo: “è un elogio dell’autocritica e del tradimento, quello di Langer. Un invito a tradire non questa o quella persona, ma semplicemente l’idea stessa che i gruppi etnici e linguistici debbano rimanere compatti”.
Dialogo
A questo punto non è un caso che il capitolo della Frontiera intitolato Trafficanti narri del viaggio di Francesco d’Assisi in Palestina durante la crociata del 1219. Siamo davanti a un eclatante tentativo di superare barriere, di parlare a un’altra lingua, e – ricorda lo scrittore – a un fallimento, perché Francesco rientrerà sì illeso dalle file nemiche, ma senza alcun risultato tangibile, anzi del tutto scoraggiato per il sentimento di impotenza maturato nell’attraversamento della frontiera. Il frate comprende e dimostra, a un tempo, quanto sia ardua la strada verso la conciliazione di prospettive e ragioni molto distanti.
E proprio a Francesco pensava lo stesso Langer quando, nel Convegno giovanile di Assisi del Natale del 1994, con un lessico estremamente vicino agli scritti del frate umbro, parlò agli astanti di riconciliazione con la natura e stile di vita democratico, moltiplicabile per tutta la popolazione mondiale. Un mondo fatto di reale esperienza di condivisione interetnica, in un rapporto paritario, fondato sulla dignità e la giustizia tra Nord e Sud del mondo.
L’assunto di Langer partiva dalla lezione esperita in Sudtirolo, e cioè che la diversità consente solo due strade: i muri di odio, forieri di epurazione, esclusione, fanatismo; oppure attrezzarsi alla convivenza, nel dialogo, nella cultura, nella legislazione, nella società.
Il mondo plurietnico, andrebbe ricordato più spesso, non è un’opinione, ma un fatto. Ed è diretta conseguenza, Fanon e Said insegnano, dell’interconnessione globale avvenuta in un rapporto di dominio e sfruttamento di popoli, i quali si spostano, fuggono, come documenta Leogrande in Albania e Eritrea, per via della sistematica distruzione del sostrato sociale, economico e politico dei paesi dominati da parte dei colonizzatori. O più semplicemente perché non si può negare ai giovani di qualsiasi luogo di desiderare ciò che è facilmente alla portata dei loro coetanei occidentali.
Per questo Leogrande e Langer pensano al vagabondo e pontiere Francesco, e per questo il sudtirolese, nella sua lettera a San Cristoforo, ricorda la forza e l’umiltà del santo traghettatore di viandanti: “prendere sulle spalle un bambino per portarlo dall’altra parte, un compito per cui non occorreva certo essere un gigante come te (…)”. E invece di fronte alla scoperta di interi mondi in fuga, i due intellettuali divisi da una generazione capiscono che essere nel giusto non basta, anzi si scoprono entrambi inermi, sovrastati, proprio come era accaduto a Francesco dopo la Palestina.
Se per Langer, quindi, all’origine dell’interesse per i conflitti interetnici vi è l’esperienza dolorosa della propria terra, nonché una militanza trentennale tra le maglie etniche europee, Leogrande viene da quel meridione d’Italia, terra di caporalato e migrazioni, di mafie e politicanti, che si può ben ritenere una delle più grandi occasioni perse del paese.
La Taranto da cui Leogrande parte e ritorna ogni volta è simbolo di un’idea di Meridione calata dall’alto, della grande industrializzazione nazionale, dove le acciaierie hanno decretato, al pari di un sisma, la distruzione dell’assetto sociale, urbanistico e territoriale della provincia.
Dunque, se guardiamo agli scritti del tarantino, il focus dei suoi interessi sembra estendersi e svilupparsi in cerchi concentrici dalla Puglia all’Italia e al Mediterraneo: dalla raccolta postuma su Taranto e l’epopea di Cito, alla vicenda del naufragio della Katër i Radës, dalla ricostruzione del caporalato pugliese alle sorti dell’Albania orfana di Enver Hoxha, e poi dei naufraghi del Mediterraneo. Con Leogrande, come per Langer, siamo dunque di fronte a un intellettuale a tutto campo, stavolta proveniente dalla nobile tradizione meridionalista di Salvemini e Fiore.
Verso la libertà
Tornando al paese delle Aquile, la prima parte del Dialogo sull’Albania, siamo nel dicembre del ’90, principia dalla crisi della guida politica albanese comunista vista e raccontata, nelle vesti di parlamentare europeo in missione estera, da Alex Langer.
Gli studenti affollano le piazze, invocano l’Europa, in molti conoscono l’italiano e considerano l’Italia un approdo e un partner naturale. L’Albania è un paese con fortissime differenze tra città e campagna e, sebbene non si capisca come avverrà, Langer registra un inevitabile processo di cambiamento che giudica fin da subito irreversibile. Quanto ai giovani, scrive: “basta ascoltarli e ammirare la loro incredibile conoscenza delle lingue occidentali per capire che l’Europa è il loro riferimento”. In questa fase – accadrà in futuro per l’ex Jugoslavia – egli intravvede chiaramente la possibilità per l’Europa di esercitare, nell’area balcanica, dopo il lunghissimo regime di Hoxha, definito un “carcere di massa”, una leadership stabilizzatrice.
Tuttavia nel giugno del ’91 la rabbia è per l’insipienza del governo italiano, reo di pretendere, con argomenti pretestuosi quali la raggiunta libertà politica del paese, il blocco delle migrazioni verso l’Italia. Sparare su chi fugge, speronare e ricacciare indietro profughi in evidente e gravissimo stato di bisogno, farà esclamare a un esasperato Langer: “Che vergogna, tutti quei carabinieri, poliziotti e guardie di finanza mobilitati a imbarcare con l’inganno e con la forza, gli albanesi delle zattere, per rispedirli in patria!”. Un intervento inclusivo e generoso, secondo il bolzanino, avrebbe invece fermato l’escalation balcanica, mentre il progetto di una sola Europa ricca non avrebbe evitato un futuro di esodi.
Poco tempo dopo “Un popolo intero, per secoli fiero della sua austera povertà e del suo senso di indipendenza, per un certo tempo si è trasformato in una folla di mendicanti, che chiedevano aiuti all’estero e i cui giovani tentavano in massa di fuggire dal paese per cercare altrove un possibile avvenire di prosperità”, annoterà il bolzanino.
Un paese in cui risorgono problemi etnici con la minoranza greca, in cui la magistratura, come l’informazione, dipende ancora dal potere politico, ma che pian piano, dal ’92 al ‘94, mostra, anche grazie alle rimesse dei numerosi emigrati, piccoli segnali di miglioramento e apertura.
Il paese di fronte
È da qui che un giovanissimo Leogrande, allo svoltare del millennio, riprende il filo, registrando da subito la biforcazione albanese: un doppio volto che passa dalla massiccia e disordinata urbanizzazione di Tirana e Durazzo alle attività criminali del porto franco di Valona.
Ormai gli albanesi si muovono in Europa col passaporto biometrico, e all’esodo del “paese di fronte” corrisponde in Leogrande l’immagine degli immigrati meridionali di un tempo: vi è la stessa mobilità del mondo rurale, dei piccoli paesi verso le aree più sviluppate della penisola.
Nondimeno l’Italia nel marzo del ’97 è colpevole dello speronamento della motovedetta Katër i Radës, in cui muoiono 58 persone. Traspare nei resoconti e nelle analisi di Leogrande, che vanno dall’accoglienza del mercantile Vlora del ’91 alla tragedia della Katës e ai tempi recenti, il desiderio di un Sud e di un’Italia migliori. È come se la vicenda albanese riflettesse ciò che l’Italia e gli italiani sono diventati. L’Albania è in parte ciò che siamo stati, sembra dire il tarantino, e non può, proprio quell’Italia una volta contadina, terra di migranti, non capire di trovarsi al cospetto forse dell’ultima civiltà contadina europea.
Leogrande dell’Albania ama la compresenza di tempi: le tracce sedimentate del fascismo e del comunismo, le ravvicinate contraddizioni, tra nuove ostentazioni di potere, lusso, e antica miseria. Del paese più giovane d’Europa scrive: “passeggiare per Tirana vuol dire attraversare (…) vari piani sociotemporali”.
Purtroppo il mancato dialogo dell’Italia con questa regione, è giudicato un fallimento che verrà replicato dall’Europa con i popoli del Mediterraneo, e allora il punto del suo lavoro sarà cercare di capire come l’impoverimento culturale europeo riesca a ridurre l’opinione pubblica a una sostanziale “indifferenza per la morte” e per il destino altrui, nella convinzione che questa incredibile indifferenza parli ancora una volta non solo delle loro terribili vicissitudini, ma di noi.
Nel frattempo l’Albania si volge ad altri paesi. Rapidamente i suoi giovani imparano altre lingue, guardano altrove. La sua classa dirigente rimuove il passato doloroso con un linguaggio sempre più falso e vuoto.
Rimozione e memoria
Eppure, venendo ai nostri giorni, verrebbe fatto di chiedersi cosa avrebbero pensato Langer e Leogrande se avessero potuto ascoltare, solo pochi giorni fa, in piena emergenza pandemia dovuta al Covid19, le parole del presidente albanese Edi Rama mentre si accinge a spedire una squadra di trenta sanitari in aiuto dell’Italia. Data l’eloquenza, l’umiltà e la ritrovata fierezza delle parole che seguono, vale la pena riportarne qualche stralcio:
“Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che trenta medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partano oggi per la linea del fuoco in Italia. (…)”, dice il presidente Rama, “Ma so anche che laggiù è oramai casa nostra da quando l’Italia e le nostre sorelle e fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l’Albania versava in dolori immensi. (…) È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere, anche Paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse perché non siamo ricchi ma neanche privi di memoria, non ci possiamo permettere di non dimostrare all’Italia che gli albanesi e l’Albania non abbandonano mai l’amico in difficoltà”.
Sono parole importanti. Oggi che Tirana non è più quell’incrocio di fatiscenza, abusivismo e disperazione, e il primo ad ammettere lo scetticismo del decennio scorso sulle possibilità di un futuro diverso per l’Albania è proprio il suo attuale presidente, le parole sopracitate mostrano a un tempo di voler rimuovere la rimozione del ’97, e di non avere complessi di inferiorità, ma gratitudine. E ancora, il fatto che circa cinquecentomila albanesi vivano stabilmente in Italia, insieme allo stretto rapporto intercorso negli anni ’90, dimostrano la produzione di relazioni e risultati positivi. È lo stesso Langer nel Dialogo sull’Albania a chiarirlo quando spiega, numeri alla mano, come l’Italia, la Grecia, la Germania, tra il ’91 e il ’93, siano stati i maggiori contributori dell’Albania. Quasi la metà delle cospicue somme elargite furono veri e propri doni, e circa il 76% del totale degli aiuti proveniva dalla Comunità europea. La proporzione degli aiuti, scrive il politico sudtirolese, chiarisce “dove cercare i migliori amici dell’Albania”. Rama con le sue parole sembra proprio riconoscerlo.
E infine, chissà se Leogrande avrebbe mai immaginato che una via del centro di Tirana, all’ingresso del Parco Grande, potesse un giorno portare il nome dell’italiano che raccontò la storia degli albanesi: Rruga Alessandro Leogrande. Una via che conduce idealmente alla piazza principale di Tuzla, in Bosnia, dove una targa color argento e un giovane tiglio, dal ’95 sono dedicati all’amico di Tuzla, Alex Langer.
Capita a volte, e forse questo è il caso, che la storia ritrovi le sue trame più esili, e con i suoi tempi lunghi cristallizzi, piuttosto che i grandi avvenimenti, una parte minuta di quei piccoli intervalli, riportando alla luce qualcosa di coraggioso e fragile di quel tutto inestricabile che è il suo fluire. Potremmo a questo punto fare nostro il motto che Edi Rama racconta in Kurban: “Mio padre era solito dire: «Niente vale di più che lasciare dietro di sé un buon ricordo».”
Metamorfosi delle frontiere
Dialogo sull’Albania inevitabilmente conduce ad alcune riflessioni di ordine generale sulle frontiere nell’ultimo trentennio. Se la frontiera è il nostro bisogno di circoscrivere per costruire, è limite e riparo, se è sempre ambivalente e permeabile, non è mai eterna né del tutto naturale. Basta osservare la storia d’Italia con le sue barriere geografiche: l’Italia dei bruzii, quella dei romani, spostano continuamente i confini, proprio come fa l’Europa odierna nel suo allargamento a Est. Vuol dire che la frontiera riguarda la nostra capacità di progettare, è convenzionale e arbitraria, e risponde alla necessità di delimitare il mondo per produrlo e ripensarlo nel tempo.
Tuttavia, proprio come lo Schmitt del Nomos della terra metteva in luce la ridiscussione dello spazio globale ad opera delle nuove potenze mondiali rispetto all’Europa dell’800, oggi l’economia e la finanza, i mezzi di comunicazione e tecnologici, obbligano a ridisegnare il globo secondo proiezioni inedite. Se i dati, il capitale, le guerre, i virus, non hanno frontiere, le ragioni stesse della lotta di classe, della difesa ecologica del pianeta, da tempo hanno superato qualsiasi frontiera nazionale e reso impotente ogni discorso che non implichi la coesistenza in un rapporto di reciprocità.
Langer prima, e Leogrande in seguito, grazie a una visione nitida, di lungo periodo, delle dinamiche internazionali, indicano la strada per gettare le basi di un futuro amico, laddove, sotto gli occhi di tutti, accade l’esatto contrario. Ovvero le frontiere diventano trincee e al futuro si sostituisce la creazione ad arte di continui nemici. Gli sbarchi, grazie a un’informazione compiacente, occupano ossessivamente il centro del dibattito pubblico e il freddo numero di profughi, di vite umane, finisce per spostare il gradimento dei sondaggi e guidare la cinica tattica di partiti vuoti e desueti, da cui emergono leader di carta, mossi da sfacciato opportunismo.
Insomma, le ragioni di xenofobia e nazionalismo, alimentate dalla crisi morale, socio-politica, di rappresentanza, della democrazia attuale, mettono le frontiere al centro della politica nazionale. I limiti, i confini, ricorda Etienne Balibar, non sono più all’esterno, sul ciglio, bensì nel cuore del discorso politico. Sicché il bisogno di sicurezza sociale porta dritti all’identità nazionale, ovvero a una difesa schizofrenica delle radici europee, benché condita di sentimenti antieuropeisti. Si difende cioè il particolare dell’Europa, rifiutandone l’universale, senza comprendere che l’uno dimora inscindibilmente nell’altro. Si difende il simbolo di Cristo, il crocifisso, si richiamano le radici cristiane dell’Europa, dimenticando il Vangelo. Si esaltano sovranità e libertà, calpestando qualsiasi costituzione o diritto.
Ciò che succede in Polonia, Ungheria, Turchia, o quello che Leogrande ha documentato nella Grecia di Alba dorata, è un virus ben peggiore e duraturo del Covid19: la comparsa di un odio etnico cieco, antico e inedito, da cui nessun paese europeo è immune.
Se neofascismo e xenofobia attecchiscono laddove regna l’esclusione a vari livelli, e i discorsi sull’identità emergono quando le difficoltà del caso sono già in stato avanzato, ecco che allora identità e frontiere finiscono per rappresentare il termometro della crisi.
Ciò che Langer e Leogrande portano alla mente è che, come la nazione è stato un progetto dirompente, plurietnico, che ha disintegrato vincoli di sangue e privilegi per solcare nuovi confini, così l’Europa – davanti a decenni in cui interi popoli si muovono nel tentativo disperato di raggiungerla – è chiamata a ripensare il suo ruolo.
È in questo contesto che Alexander Langer e Alessandro Leogrande si collocano in qualità di mediatori e pontieri, per un’idea umanissima di mondo. È duro e forse anche retorico, ancorché verissimo, constatare che, in un mondo così grande e terribile, avremmo avuto ancora estremo bisogno di tutta la loro intelligenza.
sandro abruzzese
Bibliografia essenziale
Alexander Langer, Il viaggiatore leggero, Palermo, Sellerio, 1996
Alessandro Leogrande, Dalle macerie, Milano, Feltrinelli, 2018
Alessandro Leogrande, La frontiera, Milano, Feltrinelli, 2015
Alessandro Leogrande, Uomini e caporali, Milano,Mondadori, 2008
Dialogo sull’Albania, a cura di Giovanni Accardo, Merano, Alphabeta Verlag, 2019
Etienne Balibar, La paura delle masse, Mimesis Eterotopia, Milano, 2001
Sandro Mezzadra, Terra e confini, Manifestolibri, Roma, 2016
Edi Rama, Kurban, Il sacrificio, Rubbettino, Soveria mannelli, 2018
*Quasi tutti gli scritti di Alexander Langer sono disponibili sul sito della Fondazione Langer:
La misura del mondo di Mario La Cava
*Questo articolo è stato pubblicato in precedenza qui su Leparoleelecose
Dal centro del mondo
La parabola letteraria di Mario La Cava riemerge chiaramente dal carteggio che ebbe con Leonardo Sciascia quasi ininterrottamente dai primi anni ’50 agli anni ’80 del ‘900. Si tratta di una serie di lettere raccolte nel volume Lettere dal centro del mondo, 1951-1988, dall’editore Rubbettino, in cui, a voler essere sintetici, si intersecano due direttrici: da una parte vi è lo scrittore affermato La Cava, maestro di stile, in cui il rigore etico e la semplicità del linguaggio diventeranno un tratto distintivo; dall’altra il più giovane Sciascia, ancora lontano dai suoi approdi, ovvero da quella fusione del tema politico col poliziesco, e con gli elementi del giallo, che ne decreteranno la definitiva ascesa nel panorama letterario italiano. È inoltre la storia dell’amicizia di due intellettuali di provincia, entrambi inquieti e direi asserviti al demone della letteratura, i quali cercheranno per tutto il corso della vita, tra inevitabili alti e bassi, di scrivere per rappresentare il mondo circostante. Per La Cava basti questo stralcio, uno dei tanti, di una lettera del ’56, dove descrive all’amico siciliano le sofferenze della sua intellettualmente angusta quotidianità: “Io faccio una vita poco allegra, con molti, con troppi fastidi di famiglia, che intralciano gravemente il mio lavoro. (…) Intanto i miei miserabili guadagni con le collaborazioni assorbono gran parte del mio tempo”.
Quanto a Sciascia, da parte sua scriverà a Bovalino qualche anno dopo: “La coscienza dell’inutilità dello scrivere in me ha quasi raggiunto quella della inutilità del vivere”, e poi in procinto di trasferirsi a Roma, che “Nonostante tutto, il dover lasciare la Sicilia mi travaglia di rimorsi; mi pare di compiere una specie di diserzione di fronte al nemico”, e tuttavia temporaneamente fuggirà alla ricerca di maggiore tranquillità.
La Cava non smetterà di perorare i progetti e le riviste di Sciascia, mettendolo in contatto con consulenti quali Vittorini e Bassani, fornendo gli indirizzi di Alvaro, Sinisgalli, Fortini, Pasolini, Roversi, e spedendo spesso a sue spese i libri dell’amico in giro per l’Italia. Il giovane Sciascia, in una lettera del febbraio 1954, ribadisce a sua volta: “Io mi compiaccio sempre, come di casa mia, del tuo successo che ti tocca”.
Infatti, La Cava ha tra i suoi estimatori recensori come Caproni che sui Caratteri scrive: “Moderno sì, ma anche (e questo è forse uno dei suoi maggiori segreti) classico a un tempo, e non solo per la scrittura che, apparentemente dimessa, ha invece la fermezza sapiente di un testo antico, ma altresì, e soprattutto, per questo suo saper cogliere di una persona, in pochi tratti essenziali, perfino le più sottili pazzie, e per questo suo saper distendere, in pochi concisi paragrafi (e senza l’aiuto o trucco di una sola didascalia) un intero momento dell’anima nostra, e del nostro umano costume».
Le parti però, vent’anni dopo, sono totalmente invertite, sicché nel dicembre del ’73 è La Cava a scrivere all’amico: “tu non sei uno di quelli che cambiano modi a seconda della loro fortuna. Sei uguale a te stesso”.
Dunque la parabola di La Cava, iniziata tra le due guerre, ai massimi livelli proprio negli anni ’50 e ’60, discende fin verso un lento e inesorabile isolamento dovuto a problemi fisici, all’amministrazione delle terre avite, al repentino cambiamento dell’industria culturale e della stessa società italiana.
Quella di Sciascia invece, dal Giorno della civetta in poi (Einaudi, 1961), è un’ascesa inarrestabile fino agli editoriali degli anni ’70 e ’80 sul Corriere e sulla Stampa, ai passaggi radiofonici, televisivi, alle collaborazioni cinematografiche.
Forse per riassumere i problemi non di critica ma di successo di La Cava, (la ricerca continua di editori per le sue opere, le collaborazioni numerose ma pur sempre incerte e intermittenti con i grandi quotidiani nazionali), bastano qui le parole accorate con cui Calvino lo accoglie in una lettera datata 15 marzo 1982: “(…) ho ancora una volta apprezzato la tua finezza nelle notazioni psicologiche più lievi, il tuo garbo, la tua fedeltà a una civiltà letteraria fatta di classicità e misura. Ma come far sentire una voce discreta come la tua in mezzo ai fragori assordanti dell’epoca in cui viviamo?”.
È il mercato, come sembra dire il ligure, ovvero l’evoluzione dell’industria culturale, insomma la moda e i tempi, questi sono i fattori che fanno di La Cava un isolato? Oppure è il fatto che dei suoi protagonisti così miserabili, del suo mondo – quella terra dell’osso così immobile e crudele – all’Italia del boom e della massiccia urbanizzazione, ormai non interessa più nulla?
I fatti di Casignana
Eppure c’è un’opera che, come ha ricordato Goffredo Fofi nella prefazione all’edizione del 2018, riesce a condensare tutte le qualità dello scrittore di Bovalino, per cui si può parlare di definitivo capolavoro. Mario La Cava comincia a lavorare ai Fatti di Casignana nel dicembre del ’70, finirà tre anni dopo e il libro uscirà per i Coralli di Einaudi nel ’74. È lui stesso a darne notizia in una lettera a Leonardo Sciascia: “Io ho cominciato un nuovo romanzo (…) di ispirazione etico-politica (…) su alcuni fatti accaduti in Calabria nel 1922”. Tre anni dopo, ritornando sul discorso, La Cava ribadirà a riguardo: “Parlo di cose vecchie, al solito, ma l’animo mio era teso alle vicende odierne del nostro paese (l’Italia)”. Con ogni probabilità lo scrittore di Bovalino si riferisce alla strage di Piazza Fontana, o a uno degli episodi precedenti e collaterali che inaugurano gli anni di piombo e la strategia della tensione, e che riportano l’autore agli anni del fascismo. La Cava lo definirà “il serpente nero”, questo ritorno stragista, in grado di attraversare le epoche e insinuarsi di nuovo, con tutto il suo veleno, nei gangli dello Stato. Egli riconosce in quella brutale violenza, nel ricatto, il vecchio volto del potere amorale che aveva rubato la sua giovinezza e portato il paese alla completa distruzione. Questa è la molla che lo conduce verso il romanzo storico, insieme all’intima e antica convinzione che “il costume liberale è veramente assente dall’Italia. I liberali veri sono un’eccezione, come i poeti, e possono trovarsi in qualunque partito o fuori dai partiti”.
I fatti di Casignana, dunque, se traggono linfa dalla strategia della tensione, prendono le mosse dal Decreto Visocchi che, nel 1919, aveva acconsentito all’occupazione di terre incolte da parte dei contadini. Pochi anni dopo, però, l’Italia vira a destra e la libertà di assunzione, la revisione di molti concordati, il peggioramento dei patti agrari, cambiano nuovamente gli equilibri delle zone rurali italiane. Nel frattempo a Casignana il giovane medico Filippo Zanco e l’ex brigadiere dei carabinieri Colombo, guidano i contadini alla vittoria delle comunali e all’occupazione delle terre incolte dei Nicota, la foresta Callistro. Il futuro sembra a portata di mano, ma l’epilogo non tarderà a palesare il volto del nascente fascismo: sul sogno della palingenesi meridionale, sugli ideali di fratellanza e socialismo umanitario, si abbatte la violenza squadrista. Le forze conservatrici dei principi di Roccella, di Don Luigi Nicota e sodali, i farabutti che da sempre soggiogano il paese, la faranno franca anche questa volta, e non solo nella locride, o in Calabria, ma stavolta in tutta la penisola e per un lunghissimo ventennio.
Indubbiamente, l’amaro epilogo di La Cava riporta alla mente il grumo di poteri piccolo-borghesi che schiaccia i contadini di Aliano nel Cristo, e l’indimenticata descrizione della categoria dei Luigini nell’Orologio di Carlo Levi. Se però ad Aliano non vi è nessuna speranza di cambiamento e i contadini vivono al di fuori della storia, a Casignana invece la storia stessa finalmente irrompe nel mito, sorprende e scombussola vecchi prìncipi e nuovi baroni. Dimostra che tutto può cambiare. Evidentemente è solo un sussulto e non basta. Come non basta il piglio antropologico di La Cava, quella sua acuta capacità di osservazione notata da Vittorini nei Caratteri, oppure la ferma convinzione che gli esseri umani possano cambiare il corso degli eventi, ammesso che ne abbiano realmente le precondizioni. Anche qui, come nei Racconti di Bovalino, il destino si abbatte sugli umili della costa ionica come in un rinnovato Ciclo dei vinti. Solo che stavolta non abbiamo a che fare con il capo-popolo Triglia dei Racconti, ciarliero venditore di giustizia dalla condotta bislacca e contraddittoria, ma con l’irreprensibile e generoso Filippo Zanco. Di conseguenza l’ingiustizia lascia sì ancora una volta il campo al destino, che in La Cava ha la forza tragica degli antichi, e tuttavia la sua concezione tragica, seppur preponderante, resta sempre provvisoria per via di un altro filo costantemente intrecciato al fato: si tratta della speranza. Speranza già presente nei Racconti di Bovalino, come nella famiglia del fattore, in cui i protagonisti passano dall’idillio al dramma della povertà e alla ricostituzione del nucleo familiare: “Forse ci vuole anche fortuna nelle cose del mondo; oppure date le premesse, quelli dovevano essere i risultati”, scrive La Cava, fatto sta che “la felicità anche a quel modo era possibile, là nella nuda casa del poggio, ombreggiata dalla dolce vite, dove la famiglia, dopo il matrimonio, prese a stabilirsi”.
È come se lo spirito dell’osservatore La Cava, la sua indipendenza e statura morale, i numerosi viaggi intrapresi all’estero, dalla Russia alla Polonia, a Israele, gli dessero una lucida capacità di giudizio sui luoghi vissuti, nonché una consapevolezza illuministica.
Lo scrittore di Bovalino è sì un outsider, ma è intellettualmente e moralmente legato al discorso meridionalista e nazionale. Prova ne sia quel Viaggio in Lucania del ’52, due settimane in cui lo scrittore si muove per la Basilicata quasi a continuare un dialogo con Giustino Fortunato, Zanotti Bianco, Leonardo Sinisgalli, Rocco Scotellaro. È qui che La Cava scrive: “(…) il lato negativo ha sempre la sua origine non nell’inferiorità degli uomini, ma nelle circostanze secolari della loro vita”. E bene ha fatto Giuseppe Lupo a sottolineare che la sensibilità dello scrittore è in questo “sentirsi appartato ma non estromesso dai destini di una nazione in movimento, un aderire coerente all’atteggiamento di marginalità (…) senza peraltro rinunciare a vivere la letteratura come una sorta di impegno per il bene di una civiltà periferica”.
Insomma, nei Racconti come nei Fatti di Casignana la coralità del bovalinese si sposa con la consueta lingua precisa, moderna eppur antica, che aveva fatto dire a Sciascia: “Le cose di La Cava costituivano per me esempio e modello del come scrivere: della semplicità, essenzialità, rapidità a cui aspiravo”. La tragicità degli eventi, poi, nei Fatti viene mitigata dalla sobrietà stilistica, sicché nella materia etico-politica lo scrittore riesce a fondere il suo tempo poetico, ed essere ancora una volta contemporaneo e remoto, vicino e lontano al suo tempo. Così I fatti di Casignana, attraverso un filo rosso indelebile, si collegano all’essenza contraddittoria della storia d’Italia: ai Placido Rizzotto, ai Pio La Torre, a Portella della Ginestra, alle stragi e alle tante ragion di stato, a Falcone, Borsellino, ai Georgofili, e a tutte le speranze tradite, a tutti i soprusi e le convergenze degli apparati, a tutte le servili manovre di istituzioni piegate ai raggiri.
Infine, sempre per stare alla modernità dei Racconti, e anche per chiudere con una suggestione apparentemente lontana, nel rileggerli oggi, pur trattandosi di temi e umanità molto differenti, a volte vi si coglie una aria talmente rarefatta, quella totale assenza di sentimentalismo, in una prosa così asciutta, da portare alla mente alcuni aspetti di quel particolare tentativo incompiuto di affresco poetico di sentimenti umani costituito dai Sillabari di Goffredo Parise.
Campagna e città
Per capire ulteriormente la parabola dello scrittore La Cava forse occorre scrutare un po’ provocatoriamente la storia della letteratura italiana a ritroso. Basterebbe sfogliare una delle numerose antologie presenti nell’attuale panorama editoriale, magari delle scuole superiori, dove personalmente lavoro da più di un decennio, per scoprire che della letteratura sui contadini italiani, o sul rapporto nord-sud, o sulla migrazione degli italiani all’estero, non vi sono che poche, risibili tracce. Non solo poeti come Bodini, Scotellaro, non trovano spazio nelle pagine del canone odierno, ma nemmeno vere e proprie pietre miliari della Questione nazionale come Cristo si è fermato a Eboli del già citato Levi, Conversazione in Sicilia di Vittorini, e Donnarumma all’assalto di Ottieri, riescono a trovare lo spazio che forse meriterebbero. L’elenco sarebbe lungo.
E se è vero che durante gli anni ’50-’60 l’Italia vive, contestualmente al boom economico, la riscoperta del premoderno, la stagione degli etnologi, gli studi di De Martino, tuttavia sia il marxismo che i liberali guarderanno sempre con sufficienza alle sorti della questione contadina. Lo stesso Pavese, il quale ha indagato con profondità il rapporto tra premoderno e moderno, spesso viene travisato e banalizzato fino ad assurgere a cantore conservatore di un nostalgico ritorno al passato. Per non parlare del “reazionario” Pasolini delle Belle bandiere, che attribuisce al neo-capitalismo l’accentuarsi del divario delle varie Italie per poi chiosare: “Nell’Italia del Sud la scelta politica è ancora dominata dalla miseria – economica e psicologica ”. Pasolini aveva compreso che la nuova Italia inurbata produceva non solo merce, ma nuovi rapporti sociali: “Tale nuova cultura (…)”, scriverà in una risposta pubblica a Calvino dell’ottobre 1975, “(…) ha distrutto cinicamente le culture precedenti: da quella tradizionale borghese, alle varie culture particolaristiche e pluralistiche popolari”.
Vent’anni dopo, l’ultimo intellettuale in ordine di tempo a porsi nei confronti del mondo rurale in una posizione di riflessione, ascolto, e rispetto, è stato quell’Alex Langer partito da un remoto villaggio del Sudtirolo per diventare, prima della precoce dipartita, anima dei verdi italiani, costruttore di ponti, e esempio di cittadino del mondo.
Uomini e Caporali
Ebbene, l’Italia di oggi sembra ripresentare tutti i conti delle rimozioni del passato. Il genocidio della civiltà contadina ha lasciato dietro di sé, nell’assenza di reali programmi nazionali, un deserto di paesi, colline, isole e montagne spopolate. I divari e la frammentazione non cessano di approfondirsi. Lo squilibrio sociale ed economico delle varie aree del paese, l’emigrazione costante verso il nord del mondo, la bassissima natalità, l’urbanizzazione massiccia con relativo incremento delle ingiustizie sociali e dell’indigenza, non ultimo il potere incontrastato dei clan criminali e dei cartelli politico-clientelari, restituiscono l’immagine di uno stato diviso in fazioni, in cui prevale l’egoismo territoriale, malamente mascherato da progetti di secessione delle regioni più ricche, o dalla dittatura del ricatto dei pacchetti di voti dei notabili locali.
In questo contesto, qualsiasi progetto politico naufraga per una sostanziale incomprensione delle varie parti del paese, per la complessità dei problemi di fondo, o peggio ancora, nel lungo e medio periodo, per il completo disinteresse verso la loro risoluzione.
Insomma, tornando ai fatti di Casignana, è una storia esemplare di una matrice comune italiana in cui ritornano prepotentemente l’insipienza o la collusione delle classi dirigenti, e tornano, nel recupero delle svastiche, delle intimidazioni verso le minoranze, nel cinismo machista di piccoli e puerili giovani leader, antiche pulsioni mai del tutto accantonate.
Ma ancora, leggendo di Casignana, non si può non pensare alle odierne lotte bracciantili dei nuovi invisibili, da Borgo Mezzanone a San Ferdinando, passando per l’Agro pontino, e chiedersi se è forse lo stesso disinteresse odierno per i nostri lager moderni, il lontano riflesso del disinteresse dell’Italia del boom per i contadini di La Cava.
Castel Volturno, Rosarno, la rotta balcanica, il mare nostrum, l’isola di Lesbo, i muri e le cortine messicane, sembrano le nuove Marcinelle, le Ellis Island, di un’umanità superflua, costantemente de-umanizzata, un mondo di terroni e Okies in fuga, di cui ancora una volta a nessuno interessa realmente qualcosa.
E quanto vale la vita di Soumaila Sacko, freddato a colpi di fucile mentre tenta di costruire una capanna di lamiere nei pressi di Vibo Valentia?
Quanto vale il corpo di Becky Moses, quel corpo abusato, cresciuto nella povertà, bruciato nella miseria di una favela italiana, dopo averle negato il diritto d’asilo?
Ed è un caso che a ricordare Giuseppe Di Vittorio negli ultimi anni, dopo Uomini e caporali di Leogrande, ci abbia pensato quasi esclusivamente il sindacalista italo-ivoriano, difensore dei braccianti e dei lavoratori della filiera agroalimentare, Aboubakar Soumahoro?
Ecco fin dove arrivano I fatti di Casignana. È in questo libro, dunque, che Mario La Cava ha portato gli ultimi della costa ionica nella storia del ‘900, ritrovando la sua misura del mondo, e, con essa, l’alta funzione morale di cui ha sempre investito la sua militanza intellettuale e il suo impegno letterario.
sandro abruzzese
Bibliografia essenziale
Mario La Cava, Caratteri, Donzelli, Roma 2007
Mario La Cava, I fatti di Casignana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018
Mario La Cava, I racconti di Bovalino, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008
Mario La Cava, Viaggio in Lucania, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019
Mario La Cava, Leonardo Sciascia, Lettere al centro del mondo, 1951-1988, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012
Italo Calvino, Lettere 1940-1985, I meridiani, Mondadori, Milano 2000