Etichettato: Manifestolibri
L’ITALIA MOLTEPLICE DI “CASAPERCASA”
*Questo articolo di Giorgio Galetto è stato pubblicato qui su Poetarumsilva

Chiunque sia in cerca di un punto di vista originale, moderno, non retorico e documentato sulla questione meridionale dovrebbe incontrare, tra le pubblicazioni degli ultimi anni, Mezzogiorno Padano di Sandro Abruzzese, pubblicato per i tipi di Manifestolibri nel 2015, con una bella introduzione di Vito Teti.
La formula questione meridionale è assolutamente riduttiva, a ben guardare. O meglio, in sé non lo sarebbe affatto, ma nel caso di Abruzzese diventa limitante, perché per lui si può parlare più in generale di sradicamento, di identità in bilico, di desiderio di prendere il volo avendo però radici solide e profonde nel terreno, per parafrasare una sua efficace espressione.
I punti di vista dei personaggi di Mezzogiorno Padano, chiamati a raccontarci in prima persona la loro storia di emigrati, concorrono a descrivere un quadro complesso della realtà di questi apolidi, una polifonia di voci da cui traiamo sensazioni alterne, rabbia e speranza, frustrazione e desiderio di cambiamento, senza mai perdere di vista la ricerca delle responsabilità, e senza però mai cadere nell’errore di individuare un (solo) responsabile, di banalizzare una questione, appunto, difficile da comprendere senza provare a leggerne genesi e molteplicità di sfaccettature: e cita Salvemini che lamenta da una parte «la malattia dello Stato accentratore, divoratore, distruttore; […] la oppressione economica, in cui l’Italia meridionale è tenuta dall’Italia settentrionale» ma che aggiunge poi dall’altra che tutto il lavoro di analisi e ricerca di soluzioni da parte degli intellettuali «non caverà un ragno dal buco, finché nel Mezzogiorno stesso non si determinerà un movimento energico, costante, organico, che abbia lo scopo di attuare tutte queste riforme». Difficile, come difficili sono le vite degli attori che si muovono nelle storie raccontate da Abruzzese.
Lo scrittore, attivissimo su questi e altri argomenti anche sul suo blog «Raccontiviandanti», ritorna alla narrativa con Casapercasa, uscito nel 2018 per Rubbettino. Stavolta il punto di vista è circoscritto ad un solo protagonista e il punto di partenza, anzi lo spazio di partenza, è una sola città, Ferrara, che è quella dove l’autore campano risiede da anni. In realtà siamo di fronte ad una soltanto apparente riduzione dello spettro d’indagine, perché molte di più sono le storie e i personaggi raccontati, come i luoghi coinvolti nella narrazione. La suggestione che tiene insieme tutto nasce dalle stesse esigenze di Mezzogiorno Padano, ma qui chi parla è già (fisicamente) radicato da tempo in una terra che non è la sua, e finisce con l’essere il megafono di un disagio condiviso.
«C’è solo equilibrio nella tua città, voglio dire, è tutto omogeneo, anzi è tutto…così significativo […] tutto isonomico, e evocativo. Sì, nel tuo libro la città è sogno».
Il narratore-protagonista di Casapercasa così si esprime quando, in grande difficoltà e imbarazzo, deve pronunciarsi sul libro dell’amico Filippo, dal significativo titolo di Città perfetta. E basterebbero queste parole a dare, per converso, senso e valore alla condizione del narratore, che sperimenta e quasi si fa ipostasi dell’idea di fallimento: infelicemente divorziato, lontano dagli affetti più cari, in anno sabbatico da scuola e in cura presso la Ausl. E anche colpito da un inspiegabile ronzio all’orecchio e da un deficit di coraggio che si manifesta con un peso quasi costante sul petto. Più che isonomia, anarchia; più che sogno, incubo.
Di lui sappiamo e non sappiamo: con i suoi occhi e le sue orecchie (col sibilo) sembra più un registratore di eventi e luoghi, un flâneur antinarcisista di cui scopriamo poco a poco quanto è parco nel racconto delle proprie, attualmente dolorose vicende personali; eppure gira con un taccuino su cui la psicologa lacaniana della ausl gli ha svevianamente consigliato di fissare idee e impressioni: così la simmetria e la magia della città perfetta dell’amico Filippo è rovesciata, già a partire dalle intenzioni con cui nasce il suo utilizzo, nel taccuino che lui porta con sé, e il cui vantaggio sta proprio nel fatto che grazie alla genericità e all’improvvisazione da cui nascono le annotazioni che vi sono riportate, il narratore può sfuggire a quella progettualità estenuata e imposta dalla serialità del quotidiano, per gettarsi in un’esplorazione disordinata della città e della pianura che la circonda.
Casapercasa diventa ben presto il viaggio dentro e fuori le mura di Ferrara, alla ricerca (mai precisata, né programmata, sempre improvvisata) di un senso che vada oltre l’immagine edulcorata della città illuminata dall’incanto della sua storia e dei suoi luoghi comuni letterari, culturali, architettonici, urbanistici.
Così le guide del narratore che annota attento ma senza prefissate didascalie tutto quello che il suo occhio registra, sono prima una cagna anarchica («se fosse stata mia l’avrei chiamata Bakunin») che ha come bussola il solo suo fiuto per situazioni grottesche e paradossali, e poi soprattutto (in un passaggio di testimone dantesco tra guide che sembrano però percorrere a lungo sempre e soltanto gironi infernali, senza poter intravedere la via d’uscita dal degrado) il carpentiere ucraino Giorgio Aggiustatutto, che lo porta con sé nei suoi viaggi di lavoro presto mutatisi in percorsi di conoscenza della realtà, soprattutto quella extra moenia. Poco alla volta, e per un lungo tratto, Aggiustatutto diventa protagonista assoluto, libera il protagonista e con lui il lettore da ogni filtro culturale e da ogni sovrastruttura, e diventa un po’ guru (sì, ma non come quelli spocchiosi che te la spiegano sempre, forti solo delle loro esperienze libresche e intontiti dai loro stessi vaneggiamenti esistenziali al punto da perdere contatto con la realtà), un po’ fratello maggiore del professore depresso, come quando raccontando la propria triste vicenda allarga lo sguardo, offre una prospettiva più universale sulla sua realtà del migrante: «guarda falimenti, Alecsandro, guarda quanti falimenti che tutti sanno, questo è paese pieno di falimenti…come Ucraina solo riccomolto, poi mafia, tantamafia, sono ani che segue questerobe e udienze per recupero tuttisoldi, mai niente spera più ormai, dodici mesistipendio, perde»; o come quando deve essere lui a spiegare all’attonito, ingenuo professore come funziona il “nero”, il pagamento furibusta: «firmi busta paga mille euro e diamo altri soldi furibusta […] Comenonsai questo Alecsandro, sanno tutti? È dapertutto, dovevivi?». Ed è con Aggiustatutto che vanno alla scoperta dei paesi del cratere del terremoto emiliano, dove lui ha lavorato per anni come edile, e in virtù di un po’ di tempo libero e di quello «spirito volitivo e tenace […] teso audacemente al domani» che lo caratterizza, Giorgio guida Alecsandro (così lo chiama lui) alla scoperta di Cento, Moglia, Camposanto, San Felice, Concordia, tra i prefabbricati che ospitano le scuole a Finale Emilia o a Mirandola. In questo viaggio l’uomo dalla testa quadrata e gli occhi da lupo siberiano alterna spiegazioni sull’onomastica e la funzione di piante e alberi che di volta in volta incontrano a racconti di vita personale, che si intrecciano con vicende poco edificanti degli usi e costumi nazionali (come la storia della compagna Blerina, suo malgrado coinvolta nella corruzione di un sindacato locale), per finire con considerazioni più generali di ordine filosofico: «comunismo lavoro mangiare no libertà. Dopo è venuta libertà e noi ucraini usata per cercafortuna, lavorofigo, lontano, casapercasa».
In una dialettica spesso assai difficoltosa tra città dentro le mura (e Bassani è più volte citato, dalla pisciata della cagna dispettosa nel cortile della sua casa di via Cisterna del follo, alle peregrinazioni che incrociano più o meno involontariamente i luoghi simbolo dell’opera, per terminare nel cimitero ebraico, dove riposano le sue spoglie e quelle dei Finzi Magrini) e pianura, l’occhio rassegnato al fallimento della voce narrante cattura immagini, raccoglie suggestioni che rimandano sensazioni tra loro contrastanti, distoniche, sempre in bilico in un dialogo, appunto, irrisolto tra la scoperta della bellezza (che c’è, non si può negare) e un degrado che sembra invece volerla negare.
«La periferia sa di riproducibilità», ci viene detto in uno dei capitoli più riusciti e intensi del libro, quando il protagonista, stavolta in perfetta e desiderata solitudine, si lancia in un viaggio in macchina che uscendo dalla cinta muraria lo condurrà alle porte di Verona e dell’area dello sviluppo, nei pressi di un grande centro commerciale, dove parcheggerà e dopo aver sentito alla radio la notizia della morte di Ingrao, si abbandonerà ad un pianto liberatorio. Ci arriva dopo aver attraversato prima l’area industriale appena fuori Ferrara, per tuffarsi poi nel mare aperto di quella pianura che tanto sa dell’ America delle belt, e poi di quella delle pompe di benzina abbandonate, solitaria e affascinante, come a dire che le suggestioni provenienti dall’immaginario letterario e soprattutto cinematografico americano possono benissimo essere ritrovate riprodotte qui, in un sussulto di anti-provincialismo cui veniamo richiamati, per sfuggire di nuovo al luogo comune.
Tutto il romanzo sembra paradossalmente, nascendo dal taccuino di un uomo che ci appare rassegnato e in bilico sul suo fallimento, richiamarci all’attenzione perduta per la realtà, al non abbandono ai luoghi comuni frusti per cui la città perfetta per antonomasia debba per forza restare quella e solo quella. La tentazione di lasciarsi andare a questo atteggiamento non è facile da allontanare, e lo scrittore ci fa capire di subire il fascino che emana dalla storia di bellezza e cultura della città attraverso ampie citazioni dal libro dell’amico Filippo, in cui tutto è isonomico, in cui tutto è progettato e stabilito e in cui in filigrana si legge un concetto di bellezza ideale. La luce, rispetto al taccuino che ci guida ad esempio nell’andito buio e fetido di uno stabile abbandonato, ce la fa vedere la Città perfetta di Filippo (nipote di una gloria locale nel mondo della cultura e della politica, impietosa immagine dell’arrivismo senza scrupoli e nella quale non facciamo fatica a riconoscere un personaggio realmente esistente e ben noto). E invece proprio quello stupore alternativo, quella fuga dalla serialità cieca va cercando Alecsandro nelle sue gite mai programmate, sempre all’insegna dell’improvvisazione e della scoperta; oltre le mappe, perché queste sono sempre un inganno, «confondono gli spazi con i luoghi». Filippo è il necessario alter ego di Alecsandro, non solo perché banalmente è il modello dell’intellettuale accademico integrato e “arrivato”, con quel tanto di atteggiamento indulgente di fronte a qualche compromesso fatto ad hoc (magari non suo, ma del celeberrimo e celebrato cugino Magni) in nome della cultura e della bellezza; ma proprio perché, ci dice invece il protagonista, «io non riesco a rinunciare a nessuna delle due, realtà e bellezza», e quella realtà è fatta inevitabilmente di imperfezione, di errori e di storture.
Dentro ma anche fuori dal «pentagono venuto male» che è la città riposano realtà particolari, eventi e solitudini che sfuggono alla riproducibilità cui ancora è costretta quella periferia che si appoggia sconsolata, impersonale, alle mura della città, cui è «attigua e staccata» allo stesso tempo, rassegnata ad essere un attraversamento verso la pianura circostante.
E ce ne sono tante di realtà fuori luogo che Alecsandro scopre e di volta in volta annota sul suo taccuino, che gli piace tanto proprio perché nasce concettualmente in modo tanto diverso dalla bellezza (pre)ordinata di Città perfetta. Le trascrive (e le leggiamo) con atteggiamento curioso ma a volte distante, come se non ne conoscesse nulla: perché forse è solo questo il modo per raccontare certe storie senza essere travolti dai fumi dell’indignazione, che si farebbe altrimenti rabbia o disperazione. Cominciando da quell’angelo con ali disegnate che in volo libero (per dirla coi Marlene Kuntz, citati insieme a tanta altra musica nel libro) attraversa e plana, senza mai atterrare definitivamente e ottenere giustizia piena, su tutto il romanzo, comparendo ogni tanto come un leitmotiv sottotraccia, senza essere mai nominato, insieme ai suoi genitori che chiedono giustizia, e nel quale riconosciamo la vicenda di Federico Aldrovrandi. Come per tutto il resto ci limitiamo ad osservare insieme a chi ci racconta, lo sdegno è talmente palese conoscendo i fatti che è inutile appesantire la lettura con un dato consolidato: la realtà, cui non si può rinunciare, parla da sola.
Ed è tutto il libro che conserva questo atteggiamento verso i fatti e le persone, e non perché non vi sia partecipazione, al contrario: il protagonista si descrive mentre preda della rabbia di fronte allo sproloquio intellettualistico di Filippo lo schiaffeggia con un ceffone simile al top spin di un tennista. Salvo pentirsi subito dopo, come sempre quando “esagera”, perché non ha voglia di farsi a sua volta guru, di andarci giù duro. E risuonano ancora le parole di Aggiustatutto, che commenta così, come annota sul taccuino Alecsandro, l’episodio: «Allora Alecsandro iu pensu che voi amicistudia studia ma per capiscecosa semplice basta che tu guarda, no? Gira e tuguarda chi sta intorno, certevolte basta che osservaaltri che circonda te, no? […] Poi tua dimocratia dici tutti uguale, ma chi ha soldi compracorpo di chi no ha soldi…no? E no è uguale, no? Galera per nigiriani, per maghreb, slavo, terrone, picchiafrocio, sempre stesso…no? Non serve semprestudia, Alecsandro, per capisce questo, no? […] tu ragazzo intilligente, Filippo pure intilligente, ma voi studiatroppo […] Meno univèrsita e parla con personanormale, che lavoradifatica, no?»
La spia linguistica di un’attitudine ben consolidata la troviamo in una formula che accompagna, variando appena ogni volta, la chiusa di tanti paragrafi o episodi raccontati: le espressioni «non c’è che dire», o «direi che su questo non c’è nulla da aggiungere», e ancora «e su questo anche non c’è altro da dire» sono in clausola a tanti degli aneddoti raccolti nel taccuino di Alecsandro. Sembra che il narratore, quasi succube di questa specie di tic linguistico, non ci/si voglia illudere che la realtà necessiti di chissà quale analisi o interpretazione. Così i fatti riportati non hanno a corollario se non questo scarno commento, che rende conto anche della semplicità della lingua e della sintassi scelte per servirli. Semplicità che non è mai superficialità, neanche formale, mentre è evidentemente l’opzione scelta, il faro stilistico che illumina tutto il romanzo e non un ostentato understatement: sulle vicende della famiglia Amorini, con cui si apre il libro, sul fallimento della banca che spinge Michela a tentare il suicidio e scioglie la lingua da varano del marito Athos, finora sigillata e improvvisamente mossa da furori reazionari o qualunquistici; sulle figura di Barbara, esempio di un atteggiamento sanamente ingenuo rispetto alla cultura, agli antipodi dall’ipercorretto, accademico approccio di Filippo; sulle vite difficili di Tenora e degli inquilini dei grattacieli della zona Gad; su tutti questi e molti altri, perché la narrazione, frammentata in tantissimi episodi in buona parte tenuti insieme dal controcanto antiretorico di Aggiustatutto, ci offre una quantità considerevole di varietà umane, Alecsandro non sembra volerci dire niente di più di quello che vede e trascrive. Il suo tic linguistico, quel «non c’è che dire», (che ricorda, per funzione e tono adeguato al registro di tutta la narrazione, l’and all dell’Holden salingeriano, reso in Italiano, nella vecchia traduzione di Adriana Monti, di volta in volta con le espressioni vattelapesca, e tutto quanto, e via discorrendo, eccetera) indica distanza partecipe, giudizio/non giudizio, empatia distaccata. Una volontà di narrare fotografica (e infatti il libro è corredato da un’appendice che racconta con delle foto i luoghi descritti, della città e della pianura) che anzi sottolinea che quanto ci racconta è già in sé pure troppo, che la realtà, cui non si può rinunciare, appunto, dice abbastanza di sé, mostrandosi. E chi la vuole raccontare fa già il suo dovere così, senza inventarsi nulla, senza arricchirla di nulla; e se in caso si dovesse incontrarne la bellezza, ce ne si accorgerebbe comunque.
Così «l’unica storia che forse vale la pena di trascrivere su questo taccuino» ci dice il narratore, dunque un’eccezione al suddetto understatement, è quella di Madame Pissi, la drag queen incontrata a Moglia nel bel mezzo di un colorato corteo arcobaleno, che metterebbe a repentaglio «il vincolo di sobrietà e decoro municipale», difeso da quegli uomini vestiti di verde e con bandiere biancoverdi con al centro una foglia (apparentemente) di marjuana. Insieme a loro, uomini rasati e vestiti di nero, con bandiere con al centro una fiamma: insieme vogliono impedire a Madame Pissi, imprenditrice che dopo il terremoto col suo locale notturno ha finanziato un parco giochi, di sfilare in paese.
La narrazione è policentrica, rapsodicamente alcuni temi e personaggi ritornano come le loro ossessioni, in alcuni casi. Sappiamo che c’è una cronologia solo perché il narratore, quelle poche volte che ci parla di sé, ci fa capire che il suo anno sabbatico sta per volgere al termine.
Il voluto distacco, portato di una lingua piana e intelligibile, non inganni: non sono solo le pagine citate da Città perfetta a mostrare, nell’espediente letterario dell’attribuzione a terzi di un proprio testo, che chi scrive è capace di spingersi con mano sicura nei territori di un lirismo che nel caso dell’alter autor Filippo è naturale compendio alla bellezza paesaggistica che descrive, una ricaduta conseguente e inevitabile dei contenuti sul significante: anche dal taccuino dell’improvvisato e nevrotico cronista del quotidiano si leggono pagine che descrivono a volte la poesia del degrado e dei suoi effetti emotivi, ben evidenti in pagine come quelle in cui con Aggiustatutto il narratore si spinge dentro l’abbandono e il degrado di uno stabile frutto delle «ambizioni edilizie della provincia», dal quale i due escono feriti nell’animo al punto di doversi ritrovare in un abbraccio; o il passo in cui Alecsandro non può che soffermarsi a guardare e raccontare stupito e con discrezione la gioia del suo compare-guida ucraino, che quasi balla in mezzo ai campi della pianura emiliana, che gli ricordano la sua terra: qui non è lo scrittore Filippo a lasciarsi andare ad un’aggettivazione più libera e all’uso di metafore suggestive, è la realtà stessa che sembra connotare necessariamente nel senso della bellezza e della meraviglia la lingua che la descrive su quel taccuino.
L’apolide nell’animo per un lungo tratto del suo viaggio conversa con l’uomo che spesso gli apre gli occhi sulla realtà quotidiana, e di conseguenza su quella socio-economica che entrambi, con prospettive diverse, vivono; fino a quando Aggiustatutto lo molla, e lui prosegue da solo, nonostante le sue difficoltà personali e nonostante la materna accoglienza della psicanalista della ausl, così piena di problemi. Fino al momento del ritorno a scuola e di un, forse, ritrovato stato di serenità. Ci restano però soprattutto queste parole che accompagnano quel momento di scoramento, al centro della narrazione, quando da solo, dopo la morte di Ingrao e il viaggio solitario che lo vede attraversare la pianura padana fino a Verona, Alecsandro si scioglie in pianto:
«Piango per me e un po’ anche per questo Paese bambino, per la sua grazia incosciente e la furba accondiscendenza su cui è costruito. E per la pianura, la periferia, l’intera città. A voler essere sinceri, non lo so nemmeno io perché piango, forse la verità è che non so stare solo, ecco. E che sono un po’ melodrammatico a volte. E anche bislacco. Su questo non deve esserci dubbio né tanto altro da dire».
© Giorgio Galetto
Mezzogiorno padano: Vincenzo Morra

Da Mezzogiorno padano (manifestolibri 2015)
VINCENZO MORRA
Sotto il cielo di Bologna, stavamo davanti a un bar verso
via Zamboni ed ero solo all’ottava birra. Non ricordo
ancora per quale motivo, attaccai un discorso sull’etica
per un figlio di Savater con due rumene sedute al
tavolino a fianco, di nome Sonia e Janina. Ora che
ricordo mi piaceva Sonia. Ma non fu quello. Piuttosto
nell’ebbrezza riconobbi al mio fianco ciò che nei corsi di
filosofia della Facoltà di Bologna chiamavano «l’Altro».
Erano anni che si faceva un gran par- lare di questo
«Altro». «Altro» nel seminario su Levinas, «Altro» nello
studio monografico su Sartre e Todorov. Sinceramente,
ero un po’ perplesso su questo concetto basi- lare che
attraversa la storia della filosofia di tutti i tempi per far
riflettere il genere umano su identità e differenza. Anche
perché i professori si riempivano la bocca dell’Altro, e
puntualmente finivano per farsela tra di loro, gli stronzi.
Diciamo che marcavano la differenza, più che l’identità.
Ed io, benché lo avessi immaginato più volte, non è che
potevo alzarmi nel bel mezzo delle lezioni e chiedere:
«Scusate, una domanda, in definitiva e con parole
semplici, sapreste chia- rire … ma c-h-i c-a-z-z’è s-t’A-l-t-
r-o?».
Allora, anche grazie al coraggio preso in prestito dall’al-
cool, salii per una notte su quel treno rappresentato da
Sonia e Janina. Vennero a casa mia pensando a come
fregar- mi, a dire il vero. A come fottere l’ennesimo
ubriaco italiano scucendogli qualche quattrino facile. Una
volta a casa bevemmo ancora e, dopo aver fumato tutta
l’erba che mi era rimasta, a corto di argomenti, giocai la
carta della sincerità: «sono italiano, d’accordo, ma non
c’ho una lira. I soldi spesi erano per le bollette e il
condominio. Mi chiamo Vincenzo Morra, per gli amici
Enzino. Vengo da Grottaminarda, provincia di Avellino.
Conoscete? No! Con Napoli non c’entra un cazzo! Non
vivo neppure da solo, se devo dirla tutta. Divido la casa
con un lavoratore precario delle Poste Italiane, originario
di Pavullo. Il fine settimana torna dalla ragazza,
commessa all’Ovviesse di Modena, quella in viale dello
Sport, a due passi dal Policlinico. Mai state? Non è male.
Comunque, ho un dottorato senza borsa di studio e da
quindici anni vado avanti con i soldi che mi manda mio
padre. Tutta la vita ha fatto l’agricoltore, papà, e sperava
prima o poi prendessi in mano l’azienda. Si sa come
sono i padri. Fratelli? Sì, ho una sorella, è qui in città, ha
due anni meno di me. Frequenta il Dams, vuole fare la
coreografa e, anche lei, di tornare a casa per zappare
insieme a nostro padre, non ne vuole sapere. Mia madre
Maria, invece, pace all’anima sua, è morta da cinque
anni. Una notte andava a sbarazzarsi del pattume in
campagna, ha attraversato la strada male illuminata e
non è più tornata, è stata investita da un’auto pirata.
Questo è tutto.
Non me ne vanto, di essere un mantenuto. D’accordo,
potrei aggiungere che ho scritto almeno tre libri di
filosofia contemporanea, primo in Italia ho tradotto
Gabriel Tarde, sviscerato tutta l’opera di Deleuze e
Foucault. Conosco a memoria Sartre, Camus. Però non
credo che il quadro, ai vostri occhi, cambierebbe colore.
Tutto ciò non mi ha mai dato da mangiare».
A volte la sincerità paga. Una puttana che ti rende dei
soldi non è evento da tutti i giorni. Dei cinquanta euro
che avevo offerto loro per seguirmi me ne resero indietro
venticinque, il resto andò in liquore all’anice e una
tremenda bottiglia di vodka alla pesca. Dicevano che ero
troppo carino e pazzo. Avrei voluto vedere loro a studiare
per decenni senza mai un riconoscimento economico né
accademico. Mai un vero stipendio. E comunque, detto
tra noi, non avrei mai creduto che ci si potesse divertire
così tanto senza nemmeno scopare.
Con Sonia ci siamo rivisti altre volte, ma non abbiamo
mai fatto sesso, credo per paura che non fosse sesso.
Per un po’ erano stati lunghi caffè ristretti in zona Sacro
Cuore, dietro la stazione, negli orari più improbabili.
Erano state passeggiate con la voglia di raccontarsi tutto
e squallidi cappuccini d’orzo, ordinati nel tentativo di
risparmiarmi l’odiosa tachicardia dovuta all’effetto della
caffeina. Però le passeggiate, i caffè, i cappuccini non
portavano da nessuna parte, anche perché non eravamo
proprio una coppia di peripatetici. Allora, da un giorno
all’altro, ognuno è tornato ad essere se stesso, a
starsene nel suo recinto, a prendere la forma dell’Altro.
Dopo l’identità, di nuovo la differenza. D’altronde
eravamo due extraterrestri incontratisi per caso a una
stazione di servizio. Due mondi separati: l’università e la
statale Adriatica tra Rimini e Riccione. Avremmo potuto
incontrarci di notte, ai margini di strade oscure, quando
per via del buio si attutiscono i confini, le linee di
demarcazione si attenuano, e pure i tratti salienti
diventano sfumature. Ma vedersi così come facevamo
noi, alla luce del giorno, è stata pura buona volontà,
oppure ottimismo, ingenuità. Avrei finito col dire qualcosa
di sbagliato. Non potevo offrirle niente. Quindi dopo un
po’ ho preferito tacere. Lei, credo l’avesse sempre
saputo. Dopo di ciò il telefono ha smesso di squillare.
Nemmeno io ho più chiamato.
Dalla sera in cui conobbi Sonia e Janina, tuttavia, non ho
più abbandonato questa disarmante forma di sincerità
avviata un po’ per gioco, un po’ per disperazione. È un
tratto che ormai mi contraddistingue. Un modo per
squarciare i filtri difensivi che le persone usano per
nascondere la paura, la diffidenza verso l’Altro. Senza
grossi risultati ovviamente. Il più eclatante dei quali è
stata l’amicizia col mio spacciatore. Quando abbiamo
tempo, io e Rashid ci sdraiamo sul prato a fumare e
parlare di quanta luce si trovi nel cielo di Marrakech, di
quanto ci vorrebbe a piedi da Bologna a Tangeri, o le
centinaia di ricette con cui si può preparare il cous cous
fatto in casa, quello vero, che si mangia con le mani,
condividendo lo stesso piatto insieme ai fratelli, agli
ospiti. Col cellulare mette quella musica araba
insopportabile e, ogni volta, mi riempie della migliore
erba del Maghreb.
Nella vita non si può mai dire come andrà a finire.
Magari, grazie a Rashid lo spacciatore, prima o poi mi
arrestano mentre sogno, proprio qui, sotto il cielo di
Bologna, riverso sul prato della Montagnola. Mi invento
uno sciopero della fame. Quindi, guadagno le prime
pagine dei quotidiani quale giovane icona libertaria,
radicale, della filosofia contemporanea italiana. Già mi
vedo a discutere di antiproibizionismo con Cacciari,
Vattimo, Galimberti, Pannella durante uno di quei talk-
show dove non si capisce mai niente e ognuno parla
sull’Altro. Chi lo sa! E se finissi a condurre una rubrica
sull’Espresso? Finalmente avrei un lavoro. La tachicardia
e i tic nervosi che mi porto dietro scomparirebbero.
Riprenderei a bere i mie fottutissimi sette caffè
«guatemala» al giorno, le mie sigarette fatte di tabacco
biologico e cartine dal filtro biodegradabile. Troverei il
coraggio per comporre quel numero di telefono e Sonia,
senza esitazioni, mi chiederebbe di salvarla. Una
cerimonia sobria e dell’ottimo vino. Così ci sposeremmo.
In alto, sulla collina di San Luca, promettendoci la mezza
vita rimasta. Testimone, sotto di noi, la solita vecchia
Bologna: quella degli universitari e degli internet point,
delle Nuove brigate rosse e della Lotta continua. Quella
dei motori, della Ducati, della Lamborghini, delle torri, dei
papi, dei pizzaioli egiziani, dei cantautori. Quella delle
cooperative e dei tossici, delle vec- chie radio libere e
delle nuove commerciali, delle antiche osterie, delle
puttane sui viali, del Motor show, dei chilome- tri di
portici. Bologna etrusca, senza ombrello, di muri
imbrattati e puzza di piscio, quella delle bombe a mano a
Palazzo D’Accursio e del due agosto
millenovecentottanta, che quando arriva lo Stato tutta in
coro ancora si ricorda,
ancora fischia. Quella del Roxy bar, degli zingari ai
semafori, delle grate alla finestra, degli ex compagni, dei
centri sociali e delle Feste dell’Unità che non ci sono più.
Bologna una volta la grassa, una volta la rossa che
sprangava le strade alle camicie nere, alla destra, quella
che hasta la victoria siempre, evviva la rivoluzione e
invece oggi molto diversa, da un po’ moderna, di
mercato, scura e povera, genuflessa, realista e orfana,
sola, smarrita, dimentica, frastornata, cupa. Bologna di
potere e palazzo, che parla tante e una sola lingua, in cui
non si riconosce e che nessuno più capisce, ed è rimasta
a rammentare una vecchia storia abbandonata, una
vicenda disconosciuta, mentre imperversa il partito unico
egemone e saggio della nazione, Bologna, insomma,
dirigista, trasversale e ubiqua come il suo nuovo, giovane
e spavaldo potere, arrivista e tenace all’ombra delle torri:
Bologna mia, di Sonia e del PD.
Due o tre cose su Fortini e il Berluscorenzismo
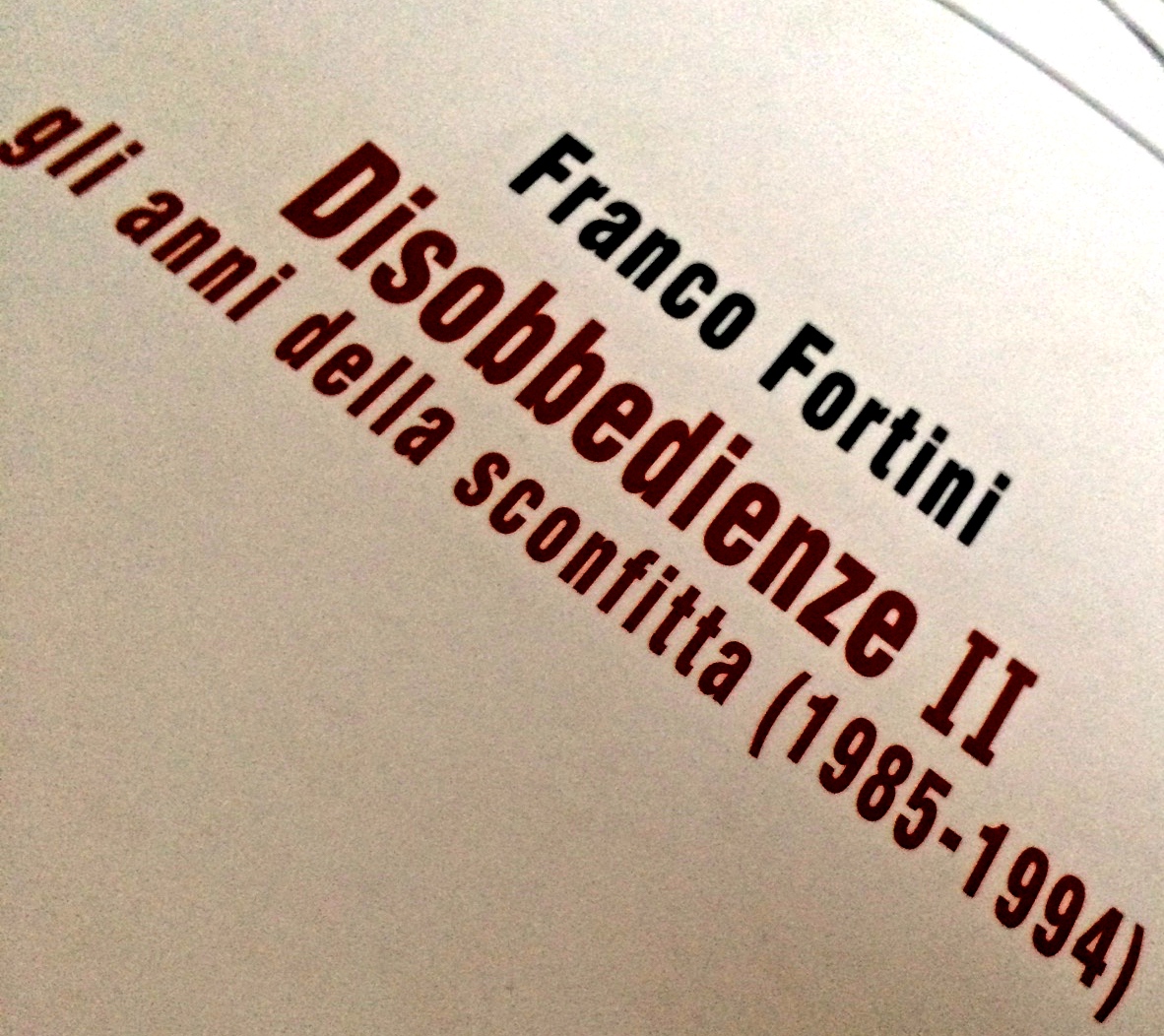
*L’ultimo brano dei due libri che contengono gli interventi di Franco Fortini su Il Manifesto (Disobbedienze I e II, Manifestolibri, 1996) nell’arco del ventennio che va dal ’72 al ’94 si intitola Cari nemici. Vale la pena riportarne l’incipit:
Cari amici, non sempre chiari compagni; cari avversari, non invisibili agenti o spie; non chiari ma visibili nemici. Sapete chi sono. Non sono mai stato né volterriano né liberista di fresca convinzione. Spero di non dover mai stringere la mano né a Sgarbi né a Ferrara né ai loro equivalenti oggi esistenti anche nelle file dei «progressisti».
Per capire le sue parole fino in fondo occorre attenzione ai tempi. È il 1994. L’anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi e del conseguente dispiegamento dell’imponente macchina mediatica di proprietà al suo servizio. È il ’94, dicevo, e la lettera, indirizzata all’assemblea “Per la libertà di informazione” tenutasi a Milano il 7 novembre del ’94, assume i toni di un vero e proprio epitaffio, infatti venti giorni dopo verrà la morte del poeta. In essa Fortini esterna tutta la sua preoccupazione: “Ma ci sono momenti”, scrive, “in cui il solo modo di dire «noi» è dire «io». (…) Questo è uno di quei momenti. Due o tre in una vita anche lunga. Bisogna spingere la coscienza agli estremi. Dove, se c’è, c’è ancora e per poco. Quando non si spinge la coscienza agli estremi, gli estremismi inutili si mangiano lucidità e coscienza”.
Il bello degli articoli di Fortini è che non vanno interpretati. Non sono moniti da presidenza della Repubblica. I suoi interventi sono l’esempio di una coscienza lucida, rigorosa, onesta, che non risparmia, anzi direi che quasi predilige, la polemica. Di conseguenza, ancora una volta in Cari nemici egli chiarisce la sua posizione denunciando “il degrado di qualità informativa, di grammatica e perfino di tecnica giornalistica nella stampa e sui video”. Prima li paragona ai primordi del fascismo, poi si corregge “Non fascismo. Ma oscura voglia, e disperata, di dimissione e servitù; che è cosa diversa”.
A chi sta parlando il vecchio e spigoloso poeta toscano? Quando invita a non scrivere un articolo al giorno, quando invita a fottersene dell’audience e dei contratti pubblicitari, e soprattutto a essere «cattivi» e non concilianti per dare l’esempio “a quei lavoratori che dai loro capi vengono illusi di battersi attraverso le strade con antichi striscioni e poi, nel buio della Tv, ridono alle battute dei pagliaccetti di Berlusconi”; a chi sta parlando?
Se ancora non è chiaro a chi Fortini si riferisca, vale la pena fare un passo indietro al 1990. È Giorgio Agamben, il 19 gennaio 1990, sempre dalle pagine de Il Manifesto, a segnare il punto stavolta. E lo fa con un durissimo articolo in risposta a Ernesto Galli della Loggia che lo aveva definito “coltissimo e raffinatissimo saggista”, invitandolo tuttavia a occuparsi di filosofia e non certo del funzionamento di politica e società. Dunque, in risposta a Galli della Loggia, l’autore di Homo sacer prima denuncia l’incondizionata “resa al potere dei media di coloro che solo per antifrasi si dicono intellettuali”, e poi andando al nocciolo sottolinea: “fra le specie infami (…) voi siete la più stolta, ignorante e ribalda e portate l’intera responsabilità della zelante esecuzione del compito che vi è stato affidato da chi vi paga e che svolgete sempre nello stesso modo, dai tempi di Goebbels a quelli di De Benedetti e Berlusconi (…). Non mi ammorbare più”, conclude Agamben rivolto a Galli della Loggia, dopo aver accusato certo giornalismo della “(…) sistematica falsificazione della lingua, dell’opinione, del pensiero”.
Ecco, Fortini, nell’articolo della raccolta intitolato Salubre insolenza, riprendendo la posizione di Agamben, sottolinea a ritroso come dalla fine degli anni ’60 in poi esista e si sia fatto strada “tutto un personale di servizio «intellettuale»” ingaggiato “per la recitazione di alcune gags o parti in commedia” a cui egli finisce per sommare un altro elemento distruttivo per la società che è “l’ipertrofia democraticistica secondo la quale si debbono rispettare tutte le opinioni, anche le più turpi, lasciar parlare anche i mentitori pubblici (…)”.
Credo Fortini sapesse bene che in pochi avrebbero “spinto la coscienza agli estremi”. In pochi si sarebbero dimessi e avrebbero pagato di persona il dissenso. In generale è accaduto un po’ come in Marcia su Roma e dintorni di Lussu rispetto al fascismo, così si è fatta strada la nostra vecchia disinvoltura. Quell’ “oscura voglia di dimissione e servitù”, che lui tanto aveva paventato, ancora una volta ha sbaragliato qualsiasi concorrenza. E i nostri stessi figli, di cui pure Fortini parlava e si preoccupava nell’articolo, ci hanno guardato e hanno appreso l’arte delle recite, delle gags. E l’Italia non solo non è più quella di Fortini, ma tutto è divenuto audience e pubblicità. Per cui se non è più vietato da leggi fascistissime esprimere opinioni, o denunciare fatti, questi vengono annegati e confusi ad arte dall’ipertrofia democraticistica denunciata dall’autore di Traducendo Brecht, fino a ridursi a flebile eco indistinta. In questo illusorio gioco di prestigio è il totalitarismo odierno, nell’impotenza della verità, nell’aumento vertiginoso e spesso indistinto di informazioni e immagini che da una parte ci illudono di essere liberi, mentre dall’altra diminuiscono fino a compromettere irrimediabilmente le nostre residue possibilità di conoscenza.
Sandro Abruzzese
*Questo articolo è stato pubblicato su Poetarum silva
Recensione a Mezzogiorno padano su Il Fatto Quotidiano
Di seguito la recensione a Mezzogiorno padano di Enrico Fierro, del 20/01/2016 , libro edito da Manifestolibri nella collana società narrata (nell’articolo c’è un refuso in merito alla casa editrice).
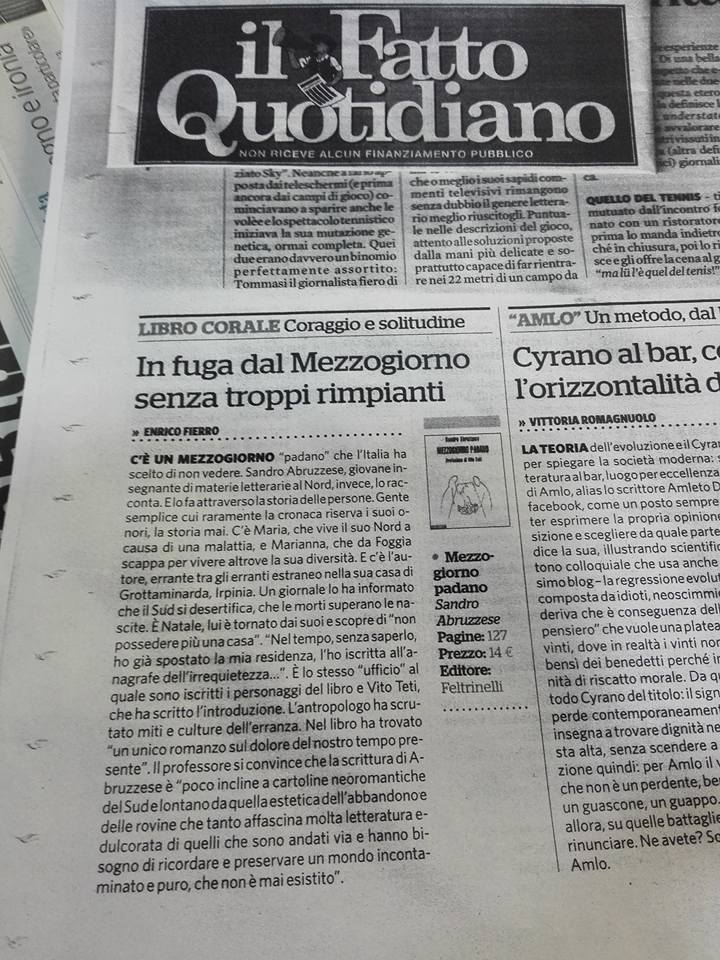

Mezzogiorno padano
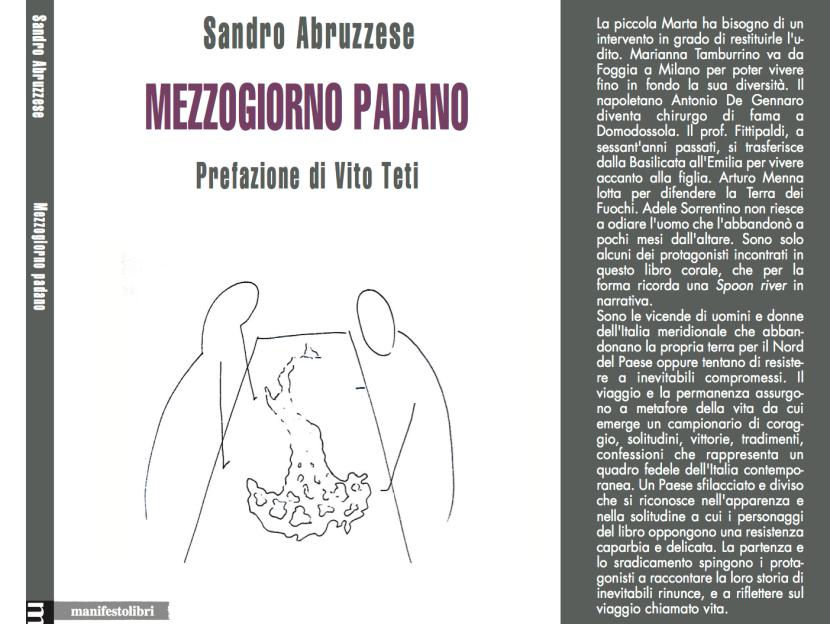
Mezzogiorno padano, Manifestolibri 2015.
Cari viandanti, è nato!
Mezzogiorno padano è un atto d’amore per il Meridione e al contempo un’espiazione. È un modo per essere in più luoghi contemporaneamente, così da poter sognare di restare e ritornare. E come al solito si occupa di Nord e Sud, di partenze e restanza, di piccole, minute storie che compongono il viaggio della vita. È disponibile dal 3 dicembre, fa parte della collana società narrata diretta da Rino Genovese, edito per la casa editrice Manifestolibri, la prefazione è di Vito Teti, la copertina di Tania Schifano.
Qui di seguito un breve estratto della prefazione di Teti:
“(…) queste storie apparentemente separate appaiono un unico romanzo sul dolore del nostro tempo presente. Queste storie, apparentemente fatte di scarti e di frammenti, raccontano le vicende eroiche e drammatiche della normalità, di un mondo di sradicati, di persone in fuga per arrivare in nessun luogo e per accorgersi che il luogo forse, come recitano i versi di Scotellaro, è là dove nasce l’erba nella terra e là dove il seme può spostarsi per trapiantarsi lontano. Come dice Salvatore Borriello, protagonista di uno dei racconti, la terra è di tutti e tutti i luoghi possono essere nostri. Le storie narrate da Abruzzese mi sembrano legate da un forte senso della vita come dolore e come fallimento. A tenerle unite è l’io narrante del racconto di apertura, Un filo d’erba, dove lo stesso autore narra un ritorno che non si realizza e non si compie, la visita nella casa paterna, dove tutto è uguale e tutto è diverso. Tutto è riconoscibile e inafferrabile ormai. Ed è questo che, stamattina, me li rende cari. È questo sentire che il mio algos e l’algos dei personaggi dei racconti corrono nello stesso fiume della vita e del tempo. È il dolore per incontri mancati, per occasioni perse, per pentimenti tardivi, per un’inquietudine che ti allontana da chi ami e ti fa vivere con qualcuno che non conosce quello che pensi davvero, che ti fa vivere da estraneo e sconosciuto”.
Seguo un verso del poeta Giuseppe Semeraro, lui scrive riempitevi le tasche di grazie. E allora grazie a tutti davvero!
S.
P. S.
Il libro lo trovate in qualsiasi libreria, basta ordinarlo. Se non volete muovervi da casa, cliccate qui oppure su Manifestolibri.
